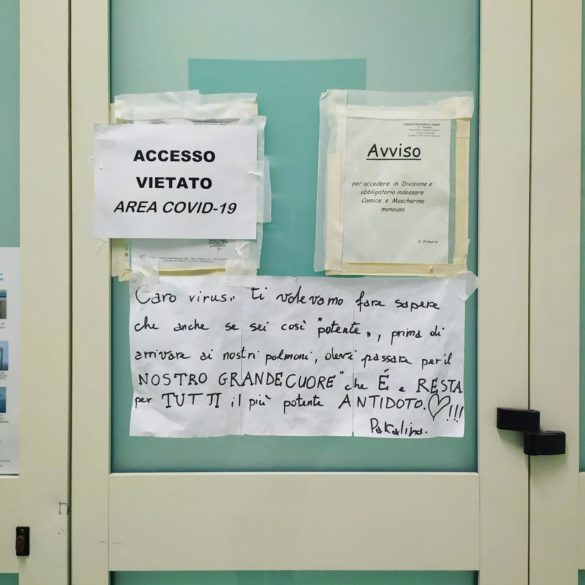“L’assistenza infermieristica è un’arte”: lo disse qualche secolo fa Florence Nightingale, la prima e più famosa infermiera nel mondo. Mai come in questo periodo, ci siamo resi conto di quanto valga il loro lavoro, svolto con dedizione nelle corsie degli ospedali, durante un evento come quello della pandemia mondiale di Covid-19 che ha messo a dura prova non soltanto la loro preparazione, ma anche le loro forze fisiche e mentali.
In Italia, uno degli ospedali che ha gestito al meglio questa emergenza sanitaria è stato il Cotugno, a Napoli. Adesso che il momento più critico sembra trascorso, bonculture vuole analizzare con Carmela Ferone, infermiera nella IV divisione dell’Ospedale partenopeo, gli ultimi due mesi vissuti da lei in prima linea nella lotta al coronavirus, prendendo in esame tutti gli aspetti fondamentali del suo lavoro:
Carmela, ora puoi fermarti un attimo e pensare agli ultimi due mesi della tua vita. Innanzitutto, come stai?
Tutto sommato bene, sicuramente sono tra i fortunati con una pandemia in corso. Gli ultimi due mesi per me sono stati cruciali dal punto di vista professionale, perché da Bari sono tornata a Napoli, per lavorare all’Ospedale Cotugno. Quando è arrivata la chiamata per l’emergenza Covid che mi avrebbe riportato a Napoli, non ci ho pensato su molto, e non ho avuto dubbi sulla risposta da dare. Man mano che l’emergenza si è evoluta, diventando poi pandemia, ho compreso che avrei dovuto affrontare professionalmente questa sfida. L’avrei affrontata a Bari così come a Napoli, non sarebbe cambiato molto. Poi essere chiamata al Cotugno non è cosa da poco.
Perché?
Lavoravo in un istituto oncologico, e lì probabilmente la situazione sarebbe stata più preservata. I pazienti Covid non avrebbero potuto dividere le stanze con gli oncologici, che sono immunodepressi. Invece sapevo che vivere l’emergenza al Cotugno, l’ospedale individuato in Campania per gestire la pandemia, mi avrebbe portato a combattere il coronavirus in prima linea. Al telefono infatti hanno specificato perché mi stavano convocando, e hanno voluto una risposta immediata. Ho subito intuito che sarebbe stata un’esperienza formativa importante, sia professionalmente che umanamente, quindi ho colto l’occasione.
Cosa ha significato, quindi, per te passare dai malati oncologici ai pazienti Covid?
Ci sono delle analogie e delle differenze: come i malati Covid positivi, anche quelli oncologici si trovano a vivere una situazione che non sono sicuri di poter superare e quindi poter sopravvivere. Si verificano delle fasi di down, e i pazienti cercano un conforto. Però, a differenza dell’oncologico, il paziente Covid permane in isolamento, e maggiormente fanno affidamento sugli infermieri perché in quel momento non possono avere contatti con i loro cari. E anche se nelle stanze entriamo bardati e non ci vedono, sei l’unico essere vivente che sta con loro durante la giornata. Si affidano completamente a noi. Quindi se il paziente oncologico tende a volte ad isolarsi, quelli Covid hanno proprio bisogno della nostra presenza, anche perché il quadro può aggravarsi in poco tempo. Gli infermieri in questo frangente sono diventati dei punti di riferimento, si sviluppa proprio un rapporto personale, e non soltanto coi pazienti ma soprattutto coi parenti. Quindi, siamo il tramite tra i pazienti Covid e i loro cari, il loro collegamento con l’esterno.
E dal punto di vista emotivo, come hai gestito il rapporto coi pazienti Covid?
Quando entriamo nelle stanze, ovviamente lo facciamo per svolgere mansioni ‘invasive’, come un prelievo venoso o l’emogas. Quindi ho provato sempre a sdrammatizzare, a scherzare e a fare qualche battuta per alleggerire il momento. Possiamo stare poco tempo nelle stanze, però è capitato spesso che un paziente ci abbia trattenuti con una scusa per alleviare un po’ la solitudine, e quindi prova ad approfittare della situazione, diciamo così. Ovviamente dobbiamo rispettare le norme di sicurezza, così spesso la chiacchierata è rimandata al telefono per dar loro la possibilità di avere anche un confronto con noi, nel caso ne avessero bisogno. Non posso nascondere che l’esperienza dal punto di vista emotivo è abbastanza forte. Fortunatamente ho trovato una squadra unita, in cui ci supportiamo a vicenda, e dove mi hanno trasmesso molta positività. Abbiamo condiviso tutto, è un lavoro di squadra. Anzi, approfitto per ringraziare i colleghi della IV divisione e il nostro coordinatore infermieristico.
Puoi riportare alcuni aneddoti sui rapporti coi pazienti?
Un paziente ha festeggiato con noi il suo compleanno: i suoi cari hanno portato la torta in reparto, e noi infermieri gliel’abbiamo recapitata in stanza, cantandogli buon compleanno. E lo stesso paziente, intervistato da una radio poi in seguito, ci ha ringraziati, sono dei riconoscimenti che ci fanno bene. Un altro nostro paziente anziano, allettato, ha scambiato un mio collega per suo nipote: non era molto vigile, e gli ha chiesto “la spremuta d’arance del nostro giardino”. Il giorno dopo, abbiamo fatto in modo di procurarci le arance, così da potergli far bere la sua spremuta. Proviamo a non farli sentire soli, e per quanto possibile assecondare le loro richieste perché non tutti superano il Covid.
Nei racconti di questi mesi, uno degli aspetti dell’emergenza che ha colpito maggiormente la gente, come documentato dai telegiornali, è la vostra vestizione protettiva. Cosa provavi mentre ti ‘trasformavi’ in un’infermiera Covid?
C’è una stanza apposita per farlo, e la vestizione è un momento fondamentale perché nel vestirti è come se ogni volta dovessi segnare il tuo destino: devi essere molto attento nel fare in modo che tutto sia indossato correttamente, perché rischi di contagiarti. Questo potrebbe essere un danno non solo per te ma anche per i colleghi, si viene meno nella squadra. Anche quando si ritorna a casa, a contatto con la propria famiglia, la paura di trasmettere il virus c’è. Le prime volte che mi sono vestita confesso che avevo un po’ di timore, nel senso che speravo di aver eseguito la vestizione alla perfezione. Quando ci vestiamo, c’è sempre un altro collega che controlla e verifica se stai seguendo l’ordine giusto, in aggiunta c’è anche uno specchio in cui poter controllare se ti sei coperto correttamente. Solo allora possiamo entrare nelle stanze dei pazienti.
Come si è svolta l’emergenza al Cotugno?
Nel mio reparto, la IV divisione, non accogliamo pazienti intensivi. Da noi il degente è curato con l’ossigenoterapia o la farmacologica. Se si aggrava, viene trasferito in sub intensiva o intensiva. Per quanto riguarda l’organizzazione dell’emergenza, il Cotugno cura le patologie infettive: erano addestrati per l’ebola che in Italia non ha dato molti problemi, quindi il personale che era già a lavoro era preparato. Il corridoio del reparto è stato suddiviso in due, a destra c’è la zona ‘sporca’ con le stanze dei degenti dove si passa vestito con la vestizione protettiva, a sinistra quello ‘pulito’ dove c’è il collega che ti passa il materiale necessario per i pazienti prima di entrare nelle loro stanze. Il percorso pulito e quello sporco non si incontrano mai. Le porte delle stanze sono sempre chiuse, ma hanno degli oblò da cui si può controllare, non entrando, il paziente. I degenti che seguo, spesso, riescono ad eseguire alcune cose da soli: tenendoci in contatto telefonicamente, come ti dicevo prima, si misurano la temperatura, ci comunicano il risultato e nel caso diciamo loro di prendere l’antipiretico, che è sempre presente in stanza, con lo sciroppo per la tosse. Quindi abbiamo un’organizzazione che ci permette di non essere bardati sempre e completamente, dal punto di vista psicologico è meno stressante, rispetto ad altre esperienze raccontatemi da altri colleghi.
La cura sperimentata al Cotugno comprende il famoso Tocilizumab, il farmaco caldeggiato dal professore Paolo Ascierto. Ci puoi spiegare la sua funzione?
Il Tocilizumab è un anticorpo monoclonale e agisce su una delle condizioni patologiche provocate dal virus: siccome il virus innesca una forte risposta infiammatoria, questo farmaco agisce proprio sull’infiammazione, che si sviluppa sia a livello polmonare che sistemico. Il Tocilizumab in poche parole aiuta il paziente a respirare meglio. In reparto l’abbiamo somministrato, e per alcuni pazienti i risultati si sono visti già il giorno dopo. Non ti nascondo che quando l’ho visto arrivare in reparto mi sono emozionata, perché mi sono sentita partecipe della lotta. Avevo un’arma in più. Quando abbiamo visto gli effetti, siamo rimasti soddisfatti anche se non è la soluzione: evita l’intubazione e quindi la terapia intensiva. Infatti, il problema più grave dell’emergenza coronavirus in Italia è la mancanza di posti in terapia intensiva. Questo farmaco ha aiutato molto in questo senso, ad evitare le cure intensive e quindi il sovraffollamento.
Sono stati presi in considerazione altri farmaci?
Inizialmente avevano scoraggiato l’uso del cortisone, in seguito hanno compreso di doverlo inserire nella terapia ad un certo punto del decorso, perché funzionava meglio ed interrompeva la cascata infiammatoria. È stata usata anche l’eparina, perché una delle complicanze del Covid è uno squilibrio cardiovascolare. Principalmente abbiamo utilizzato antivirali, da quelli somministrati ai pazienti HIV a quelli affetti da malaria. Sono stati tutti dei tentativi, delle associazioni che sono state fatte perché questi farmaci inibiscono la replicazione del virus.
Quali sono stati i risultati?
Avendoli somministrati in associazione, sono ancora in fase di studio. Non ci sono ancora certezze se effettivamente sono efficaci anche col Covid. Una supposizione riguarda il Kaletra, farmaco somministrato nei pazienti HIV: nel mio reparto, nessun paziente malato di HIV ha contratto il coronavirus. Adesso non siamo sicuri sul perché non hanno contratto il patogeno, potrebbe essere la terapia antivirale che seguono col Kaletra, che non soltanto quindi risulterebbe efficace per la sieropositività ma anche per il Covid. Essendo un nuovo virus, non lo conosciamo ancora bene.
Molti si sono meravigliati che queste sperimentazioni siano state fatte al Cotugno o al Pascale, ospedali del sud Italia che hanno poi dettato la linea farmacologica da seguire nel resto del Paese. Secondo te, che sia partita da Napoli la lotta italiana al virus, è più una conferma o una sorpresa?
Ion non sottovaluterei il Cotugno, o il Pascale. Soprattutto siamo per primi noi del Sud che non dovremmo sentirci inferiori. Non apprezzo questo stupore. Anzi, mi dà fastidio sentire questi toni sensazionalistici: posso dire che è fantastico che il Cotugno ha affrontato bene l’emergenza, così come al Pascale si è trovata subito una sperimentazione che ha dato speranza. A questo proposito, vorrei esprimere un desiderio: vorrei che in futuro, le persone non si meravigliassero se una cura o un buon esempio proverrà da un ospedale del Meridione. Le eccellenze ci sono anche qui a Napoli, e se magari vogliamo analizzare la situazione nel dettaglio, partiamo anche svantaggiati rispetto al resto d’Italia perché non abbiamo gli stessi mezzi delle altre aziende ospedaliere italiane. Nonostante non ci siano le condizioni ottimali, siamo arrivati comunque a questi risultati. Passa il messaggio: “ok, ora ve la siete guadagnati la credibilità”. Invece no, dovrebbe esserci concessa a prescindere dai risultati ottenuti nella lotta al Covid.
In questi primi giorni di Fase 2, qual è la situazione al Cotugno?
Il momento più critico è stato quello di marzo, con tutti i reparti pieni. Adesso, con la Fase 2 stiamo riuscendo a ricaricarci dopo i due mesi molto impegnativi che abbiamo vissuto in corsia. Comunque siamo preoccupati, perché temiamo che la gente non rispetterà le regole basilari per evitare la diffusione del Covid. Attendiamo gli sviluppi tra due settimane, e speriamo.
In un tuo post su Facebook, diventato virale, hai scritto: “Vado alla ricerca di un goal nel cuore e nella vita delle persone che troveranno in me un compagno con cui vincere la loro partita, quella partita che è anche nostra!”: cosa è significato essere un’infermiera durante l’emergenza Covid?
La metafora calcistica è partita dal fatto che noi infermieri, dato che non possiamo farci riconoscere, scriviamo i nostri nomi sul retro delle tute, come i calciatori. Sicuramente, ho percepito un forte senso di responsabilità non soltanto verso il paziente ma anche verso la collettività, perché siamo in una fase d’emergenza. Quindi evitare che una persona ne contagi un’altra è fondamentale. Essere infermiera in questa fase ha acquistato vari significati perché si è innescato anche una sorta di conflitto interno: l’infermiere in Italia, prima dell’emergenza, era visto come il subalterno del medico, come se non avessimo una nostra dignità professionale. Adesso siamo visti come degli eroi. Quindi si rimane un po’ spiazzati da questo ribaltamento di opinione da parte della gente. Noi usciamo di casa tutti i giorni solo per andare a lavorare, non è cambiato nulla, anche se è un periodo particolare.
Forse è stato compreso meglio il vostro lavoro…
Spero che comunque questa stima nei nostri confronti non si interrompa. L’opera che ha creato Banksy (all’ospedale di Bristol, si chiama Game Changer ndr.) dedicandola alle infermiere è significativa, per esempio: con un bambino protagonista, fa comprendere che soprattutto le nuove generazioni devono apprendere il valore del lavoro che svolgiamo.
A proposito di partite, secondo te questa col Covid è stata vinta?
La partita col Covid non è vinta, l’attenzione potrebbe calare e il contagio potrebbe riprendere forza. Mi metto anche nei panni delle persone che sono rimaste in casa per due mesi, però riprendetevi quel po’ di libertà che ci hanno concesso senza esagerare. Ci sono colleghi che hanno perso la vita in questa battaglia, e quindi chiederei solo un po’ di rispetto.