Sfogliando le pagine di «Il Selvaggio» – che con alterne fortune esce dal 1924 al 1943 prima a Colle Val d’Elsa, poi a Firenze, a Siena, a Torino e infine a Roma – si è tentati di scambiare la spregiudicatezza di Mino Maccari per l’opposizione di un antagonista se non addirittura per antifascismo. Ma non è così.
Se nelle sue feroci incisioni i gerarchi sono repellenti, grotteschi, mostruosi, è perché il grande disegnatore non smette mai di fustigare il malcostume dell’epoca, nonostante la sua adesione al regime, più volte rievocata: «Sono stato fascista, un fascista a modo mio. Nel ’22 avevo ventiquattro anni, e a Colle Val d’Elsa, un paesino in provincia di Siena, ci s’annoiava da morire. Quando venne la marcia su Roma, ci andai anch’io con qualche amico, al grido di “O Roma o Orte”. Era un’avventura da boy-scout, nessuno ci torse un capello, non ci furono incidenti: neppure uno di noi a cui uscisse il sangue dal naso. Poi venne il ventennio e il regime ci avvinse, ci avviluppò nelle sue beghe interne, nel gioco dei suoi clan. Per Colle Val d’Elsa fu una scoperta: schiaffi, finti duelli, querele. Con le vignette e le filastrocche mettevamo un gerarca contro l’altro a volte con un po’ di incoscienza». Ardente fascista agli inizi, vicino allo squadrismo quando crede nella capacità di persuasione del manganello raddrizzatore, diventa sempre più tiepido negli anni del consenso generalizzato, in cui si moltiplicano i profittatori, gli adulatori, gli arrivisti, gli intellettuali sedotti dal potere. Se ne distacca nel momento in cui vede prevalere l’odiata ideologia nazista. Nel settembre ’44 raggiunge le forze partigiane, partecipando alla resistenza. Sin dal ’43 si era già clamorosamente congedato dai miti del fascismo con la “Rassegna Dux”, singolare ciclo di immagini satiriche su cui si staglia la figura del duce. Le sue tipiche pose si risolvono ormai nella derisoria pantomima in cui il disinganno storico del paese coincide con lo scacco privato del pittore.
IL MALEDETTO TOSCANO
Nei vari numeri di «Il Selvaggio» emergono gli estri e gli umori del maledetto toscano, ma anche le contraddizioni del tempo. Non si può trascurare Strapaese, che si proponeva di esaltare i valori rivoluzionari dello spirito paesano e nazionale in opposizione al cosmopolitismo moderno, industriale, cittadino di Stracittà. Se Mino Maccari incarna l’insolente spavalderia di Strapaese, Massimo Bontempelli è l’instancabile profeta di Stracittà. La modernizzazione è la bestia nera di Maccari, pronto a buttare a mare cinematografi e tabarin, snobismi anglofrancesi e psicoanalisi viennese in nome della tradizione. Se Bontempelli, che ha un debole per il jazz e i balletti russi, il novecento e i grattacieli, si arrischia a vedere nel cinema l’arte del ventesimo secolo, Maccari tuona contro la “bontempellagine” di chi rinuncia alla propria identità per riconoscersi nei modelli stranieri: «Noi siamo poveri italiani: crediamo nell’arte e non nel cinematografo. Quando noi sapremo fare film come gli americani, saremo tutt’al più come gli americani. È lo scopo dell’espansione intellettuale italiana?». Cosa c’entriamo noi con la glorificazione della morale yankee dei marinai, dei vigili del fuoco, dei boxeur? Non c’è film americano dove non si faccia l’esaltazione dell’“american way of life”. Se il cinema è uno straordinario strumento di prestigio per il popolo che lo produce, perché dobbiamo spalancare le porte alla produzione hollywoodiana?
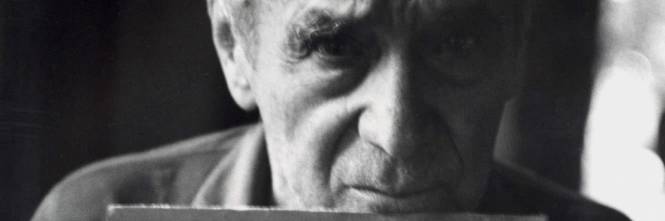
Nei primi anni trenta, quando il muto cede il passo al sonoro, l’atteggiamento di Maccari e dei suoi selvaggi è rissosamente polemico nei confronti dei tentativi più ambiziosi della “rinascita” del nuovo cinema italiano promossa dal regime. Non gli piacciono le presunte novità di Terra madre e Resurrectio di Alessandro Blasetti e degli altri velleitari film campestri che mettono in scena una ruralità di maniera con contadini che ballano il saltarello e cantano nei cori delle sagre paesane. La polemica non risparmia la Cines, che continua a sfornare insulse commediole, e Emilio Cecchi, il critico letterario che per quasi due anni ne è il direttore artistico. Il gusto dello sberleffo allegramente distruttivo prevale sulle argomentazioni critiche «Cines rasa al suolo. Dria Paola messa a bollire in una pentola di pece ardente in Piazza Navona: con ballo di ragazzini».
POLEMICA CON IL CINEMA ITALIANO
Si prende in giro apertamente Armando Falconi, che in Rubacuori si crede ancora un grande tombeur de femmes: «Il vecchio attore che, con l’epa mal trattenuta nelle brache, l’occhio smorto, le braccia penzoloni in avanti, ballonzola alla moda dei negri, non fa ridere, fa pena». Il successivo Patatrac, di nuovo con Falconi, suscita l’indignazione: «Ci si chiede se, in un paese nel quale persone che non si guadagnano il pane con una certa fatica si contano sulle dita, sia decoroso, edificante, dare in pasto al pubblico italiano un film dove la vita scioperata, scioccamente gaudente di talune categorie, viene trattata con tanto rispetto e benevolenza».Pollice verso anche per Acciaio, rovinato dall’atteggiamento “turistico” di Walter Ruttmann, il regista tedesco chiamato per l’occasione in Italia: «Il paese, la fabbrica, gli italiani hanno fornito gli elementi. Il regista li ha adoperati malamente. Ruttmann non sa fare un film, sarà bene rispedirlo al suo paese». Non si salva niente e nessuno: «Quello che è stato prodotto finora fa rivoltare lo stomaco, è la sciatta pittura di una piccola borghesia mediocre e gretta, che non sa muoversi, o di un paesanismo di maniera che non esiste e non esisterà mai. Noi abbiamo affidato a mani assolutamente inadatte questo che sarebbe un prezioso strumento, capace di indirizzare potentemente le folle verso costumi e passioni degne di un popolo vivo e deciso a vivere. I film che abbiamo prodotto fino ad oggi descrivono al mondo un’Italia imbecille e meschina, di cui è enorme che non ci si vergogni».
Gli intellettuali che esaltano il cinema come espressione artistica sono anch’essi nel mirino di Maccari. La copertina del 30 aprile 1935 è dedicata a Giovanni Gentile, autore della prefazione a Cinematografo di Luigi Chiarini – un nome importante nella nomenclatura dell’epoca, direttore del Centro Sperimentale di Cinematografia – con il faccione del barbuto filosofo siciliano che spunta dal salvagente, sollevando le braccia verso l’icona di Mae West mentre la nave Attualismus va a fondo. Nella quarta, il filosofo si toglie il cappello davanti a una spiritata ballerina, che nella dida (“L’arrivo della filosofia a Hollywood”) lo saluta con un disinvolto “Ciao, John”. Nessuno sconto neppure per Luigi Freddi, l’onnipotente Direttore generale della cinematografia, che a bordo di un elefante orchestra la battaglia di Zama alla mostra di Venezia per lanciare Scipione l’Africano, il kolossal imperiale di Carmine Gallone.
Nel 1938, alla fine di un’ampia recensione di Un giorno alle corse di Sam Wood con i fratelli Marx, di cui in piena campagna razziale mostra di apprezzare le «clownesche macchinazioni» e l’«humour feroce», torna con rinnovata perfidia sul cinema italiano più che mai addormentato: «Si è detto proprio in questi giorni che occorre fare del pubblico il giudice supremo. Nel nostro caso, aggiungiamo che occorre però fare il pubblico: cioè spaventarlo, muoverne le passioni, svegliarlo da quel torpore che indubbiamente a furia di De Sica e di Besozzi l’ha ridotto a desiderare soltanto le cause facili, le cause vinte, da liquidarsi con qualche insipido applauso e con la stessa identica stereotipa formula che, tra le labbra odorose di macedonia extra delle piccoloborghesi frequentatrici delle prime, suona indifferentemente assoluzione e condanna. Cinematografia italiana! Paradiso di circostanze attenuanti! Quando vedremo nella tua gabbia un colpevole, che abbia veramente e gravemente peccato d’intelligenza?».
L’INCONTRO CON STROHEIM
L’idiosincrasia nei confronti del cinema è la rimozione del guastafeste che si ribella al malcostume della società dello spettacolo e respinge con impietosa ironia ogni forma di contraffazione. Perché, in realtà, dice Maccari, «noi non siamo nemici del cinema, come non siamo nemici dell’automobile, dell’ascensore, del grammofono, degli accendisigari, della radio e di tanti altri prodotti della tecnica, dei quali accettiamo i servizi, senza riconoscerne la divinità, pretesa e postulata dai pessimi interpreti e apologeti dei nostri tempi». L’esorcismo si risolve in conversione grazie all’incontro sullo schermo con Eric von Stroheim – lo Stroheim di Mariti ciechi, Femmine folli, Sinfonia nuziale, Il gran Gabbo – finalmente un personaggio a cui riconosce personalità, istinto, stile, gusto, fantasia e, naturalmente, sfortuna: tutte cose che gli piacciono molto, anche al cinema. Si tratta davvero di una folgorazione se, nella folla di immagini evocate da Maccari, non c’è nessun altro che ricorra più del grande regista-attore, impettito nella divisa bianca da ufficiale austriaco, con tanto di monocolo, cranio rasato, orecchie a sventola. L’altro personaggio a cui va l’esplicita simpatia del pittore è Mae West, il sex-symbol biondo platino dalla formosa sensualità in cui apprezza la donna disinibita, sfacciata, candidamente amorale. L’irriducibile energia dell’attrice e la sua scandalosa popolarità si impongono con Lady Lou – La donna fatale di Lowell Sherman, dove con le sue battute micidiali tiene testa al capitano dell’Esercito della Salvezza Cary Grant: «Lady Lou: quanti ricordi! Quando partimmo per la guerra, Lady Lou aveva già fatto le sue campagne, ma fu lei a salutarci, dal varietà dove ci fermammo prima di montare in tradotta; fu lei, Lady Lou, a darci l’ultima “mossa” in grande stile. Migliaia di girls non ci hanno saputo, più tardi, ripagare di quell’inobliabile ancheggiare».
LE PERSONE VIVE SULLO SCHERMO
Nei volti di questi due grandi irregolari l’artista senese vede una sorta di scaramantico contrassegno dell’avventura umana, attraverso il quale si riconcilia con il cinema, che influisce sulla stessa costruzione del disegno e sul taglio dell’immagine, fino a accogliere in modo sempre più esplicito le suggestioni della sala buia, la singolare intensità emotiva delle figure in movimento. Il bilancio alla fine è addirittura capovolto, tutto paradossalmente a favore del cinema. «Siamo giusti, quanti simpatici uomini e care donnine non ci ha fatto conoscere il cinema?», dirà a un certo punto. «Oseremo dire che quando s’è cercato qualche persona viva e vera s’è dovuta andare a cercare sullo schermo? Sarebbe una condanna troppo grave per la società moderna affermare che soltanto nella finzione e nella recitazione la nostra umanità sappia esprimere qualche accento capace di appassionare e di entusiasmare la folla; ma è un fatto che i ceti, le categorie sociali si sono talmente annacquate e afflosciate, hanno talmente perso il proprio carattere, che sembra sia di spettanza del cinema tenerne in alto le tradizioni». Nel dopoguerra collabora a «Il Mondo» di Pannunzio con i suoi disegni satirici, in cui prende di mira potenti funzionari, commendatori, capitalisti, alti ufficiali che contano sulla nuova classe dirigente per prosperare all’ombra dei partiti di governo. Si dedica prevalentemente alla pittura, mentre i critici per la sua opera grafica fanno giustamente i grandi nomi di Grosz, Daumier, Ensor, Toulouse-Lautrec. Il rapporto con lo schermo si affievolisce fino a scomparire quasi del tutto se non fosse per la sarcastica raffigurazione di produttori e faccendieri del sottobosco cinematografico.

