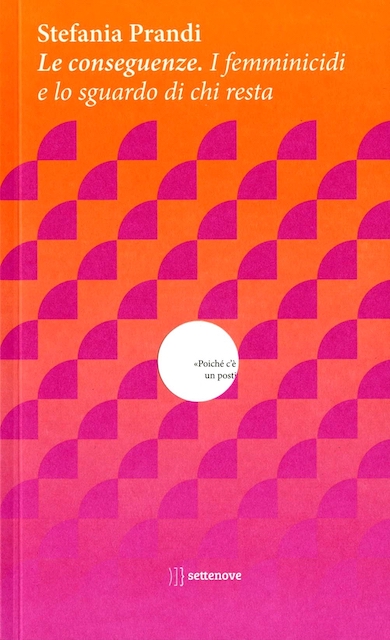Un femminicidio, racconta Vera Squatrito, è una bomba atomica. Sua figlia, Giordana Di Stefano, vent’anni, madre di una bambina di quattro, il 7 ottobre del 2015 è stata uccisa dall’ex fidanzato. Lui, poco prima che Giordana rientrasse a casa, l’ha uccisa con quarantotto coltellate.
«Le famiglie si distruggono. È molto difficile riuscire a capirsi nel dolore che non finisce mai. Ci sono rabbia, sensi di colpa, e una forma di depressione invisibile e costante. Io ho perso tutto, non ho più niente. Sopra di me, ho già la stessa terra che ha mia figlia: sono morta». Il dolore straziante e commovente di questa donna è solo un singolo tassello delle dodici storie che ha raccolto con una rara maestria giornalistica Stefania Prandi, autrice del significativo libro “Le conseguenze. I femminicidi e lo sguardo di chi resta” (Settenove, 120 pagine, 15 euro). In questa raccolta di commovente bellezza, Stefania Prandi valorizza lo sguardo dei sopravvissuti a questo terrore.
Ci sono le madri, i padri, le sorelle, i fratelli. E poi i figli: “gli orfani speciali” che raccontano, parlano, testimoniano la complessità di andare avanti, vivere, superare il lutto, tentare di archiviare un trauma che non conosce forma, non ammette tregua. Orfani di madre: per i figli delle donne uccise quasi sempre dai propri uomini c’è una parola, un posto simbolico. Per le madri e i padri che hanno perso una figlia, invece, neppure le parole trovano una consolazione, una protezione a quel tormento. Così, la memoria protegge e congela tutto: le foto, i luoghi, i vestiti. La bravura della giornalista, e il coraggio di una meritoria casa editrice nata con l’impegno di pubblicare e valorizzare testi per la prevenzione della violenza di genere, è l’abilità rispettosa dell’ascolto. Le parole delle vittime, dosate con sfumature mature e con un controllo delle emozioni, sono quasi tutto in questo libro. Poi, però, c’è anche lo sguardo dell’autrice che riesce a restituire l’intimità e la dignità a un dolore e l’urgenza politica a una denuncia. Le conseguenze non si fermano ai ricordi, ma sono molteplici e si espandono: dai problemi economici alle battaglie processuali, dai risarcimenti alla silenziosa invisibilità, toccando le parole sbagliate e colpevoli della stampa, dei tribunali, della gente. Tutto ricorda, preoccupa e ferisce: ancora. bonculture ha intervistato Stefania Prandi.
“Le conseguenze”, dopo un femminicidio, appartengono più allo sguardo silenzioso di chi resta, ma non solo. Questo fenomeno è spesso circoscritto nel privato, nella vita domestica. Dopo un numero spaventoso di donne uccise, abbiamo maturato un’urgenza politica su questo tema?
La narrazione mediatica dei femminicidi, termine con cui si intende la morte o la sparizione di una donna a causa del suo genere di appartenenza e del suo essere donna per motivi di odio, disprezzo, piacere o senso del possesso, è relegata in genere alla cronaca nera e a un modo morboso di riportare le notizie. Ho pensato che fosse necessario trovare delle chiavi diverse per descrivere il fenomeno della violenza estrema contro le donne. Ho quindi deciso di concentrarmi sulle conseguenze dei femminicidi sulle famiglie, prime cellule della società, e sulla società nel suo complesso. A pagare le conseguenze di questi crimini sono madri, padri, figli, sorelle, fratelli. A loro restano i giorni del dopo, i ricordi immobili appesi ai muri, trattenuti dalle cornici, impressi nei vestiti impolverati, le spese legali, i ricorsi, le maldicenze nei tribunali, le giustificazioni. Sempre più familiari intraprendono battaglie quotidiane, piccole o grandi, a seconda dei casi. C’è chi scrive libri, chi organizza incontri nelle scuole e nelle piazze, chi lancia petizioni, partecipa a trasmissioni televisive, raccoglie fondi per iniziative di sensibilizzazione, fa attivismo online. Lo scopo è dimostrare che quanto si sono trovati a vivere non è dovuto né alla sfortuna né alla colpa di chi è stata uccisa, ma ha radici culturali ben precise. La reazione all’infinito del dolore individuale, che da personale diventa politico, fatica a essere riconosciuta a livello istituzionale e mediatico. Eppure, sono in molti a non smettere di combattere contro l’invisibilità e il silenzio, nemmeno a distanza di decenni dalla morte delle figlie, delle madri, delle sorelle. Il vero amore è questo, non quello degli uomini che le hanno uccise.
Nel nostro Paese, mentre gli omicidi diminuiscono, viene uccisa una donna ogni 60 ore. L’assassino è un padre, un marito, un compagno: non è il mostro nero. L’emancipazione, la libertà conquistata, la volontà di essere fautrici del proprio destino, la semplicità di un rifiuto sono ancora delle condanne a morte per le donne?
Viviamo in una società fortemente discriminante nei confronti delle donne che faticano ad avere ruoli decisivi nei vari ambiti, dalla cultura alla politica, e una rappresentanza adeguata nella vita pubblica. Non sono i tentativi di superamento della disparità di genere a condannare a morte le donne, ma la cultura retrograda e sessista che ancora condiziona uomini e donne. Il numero delle violenze di genere e dei femminicidi non diminuisce, nonostante le campagne di sensibilizzazione e il gran parlare che si fa attorno al tema, spesso usando modi e termini sensazionalistici e colpevolizzanti per le vittime. È evidente che ci sia qualcosa di sbagliato se la situazione non migliora. Penso, ad esempio, agli slogan che raccomandano alle donne di avere coraggio, di uscire dal silenzio, accompagnati spesso da immagini di volti femminili tumefatti, insanguinati o da bocche cucite. Perché non cambiare prospettiva? Perché non concentrarsi su chi compie la violenza di genere, che sia economica, psicologica, fisica? Dove sono gli uomini? Perché non sentiamo quasi mai parlare delle loro responsabilità? Di chi compie le violenze non si parla quasi mai, se non in termini spesso condiscendenti.
Le rappresentazioni simboliche utilizzano molto spesso la gelosia per spiegare i casi di femminicidio. La gelosia arriva a “giustificare” la violenza, il raptus tanto evocato dalle difese. In realtà quasi tutti i femminicidi sono preceduti da una lucida premeditazione, è così?
I pretesti dello scoppio d’ira e dell’infermità mentale sono usati con frequenza dai legali degli assassini delle donne uccise: in genere fanno parte della strategia difensiva. Nonostante una ricerca dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca (condotta su venti sentenze di condanna tra il 2011 e il 2016, in diverse parti d’Italia) dimostri che in genere i femminicidi sono «l’esito di una lucida e irrevocabile programmazione pianificata nel tempo», metà delle assoluzioni è dovuta al riconoscimento dell’incapacità di intendere e volere.
In molte testimonianze rileva un aspetto doloroso: la scarsa efficacia delle denunce. Spesso le denunce sono sottovalutate dalle stesse forze dell’ordine. Parlate di occultamento della violenza maschile. In che senso?
Rispondo citando le parole di un uomo che nel libro compare con lo pseudonimo di Domenico, per tutela dei nipoti minorenni. Sua figlia, chiamata Adele nel libro, è stata uccisa dal marito, adesso in carcere. Domenico deve occuparsi dei due bimbi, sopravvissuti all’omicidio della madre.«Non possiamo accettare che quando una donna denuncia maltrattamenti in famiglia venga abbandonata, che un terzo delle donne in Italia sia vittima di violenza, che il 91% per cento dei reati di stalking sia commesso da maschi. Non è possibile che le condanne siano appena il 42,5% e che le donne subiscano una vittimizzazione secondaria durante i processi perché si entra nel privato, si indaga la loro sessualità, le si colpevolizza. L’assassino di mia figlia è stato condannato a trent’anni di carcere».
Ha incontrato tanti sopravvissuti: madri, padri, fratelli, sorelle, figli che vivono i giorni che seguono con dolore, solitudine, abbandono. Quali sono le conseguenze per chi resta?
Queste famiglie vengono lasciate sole in un dolore inconsolabile, nella lotta per ottenere giustizia e risarcimenti, nella fatica di crescere bambini e bambine senza più madri. Una parte del libro è dedicata agli «orfani speciali», cioè i figli di madri uccise dai padri. A coniare questa definizione è stata la compianta Anna Costanza Baldry, criminologa e docente di Psicologia sociale e giuridica all’università Luigi Vanvitelli di Napoli. Non avere più la madre perché l’ha uccisa il proprio padre è il trauma nel trauma. Eppure, in Italia, così come in altri paesi, manca un registro ufficiale, non si sa nemmeno quanti siano gli «orfani speciali». Si stima, invece, che 427.000 minori, in cinque anni, in Italia, abbiano vissuto la violenza sulle madri tra le mura di casa. Bambini e bambine che hanno assistito direttamente ai maltrattamenti oppure hanno visto i lividi, le ferite, le porte, le sedie e i tavoli rotti in casa. Nel libro si affronta anche la grave questione delle donne scomparse, che non rientrano nella conta ufficiale dei femminicidi. Assenti anche quelle morte per problemi di salute causati da una vita di violenze – non solo dovuti alle ripercussioni delle botte e dei maltrattamenti fisici, anche alle pressioni e ai ricatti psicologici – e quelle che si suicidano per sfuggire agli abusi e alle vessazioni. Per l’Organizzazione mondiale della sanità, le donne che subiscono abusi dal partner soffrono di livelli più alti di depressione, ansia, fobia, con maggiore propensione al suicidio delle altre.
Un tema importante è quello del linguaggio. La stampa, infatti, non racconta solamente un fatto di cronaca, ma rappresenta e influenza con i simboli e le parole i fatti sociali. Cominciamo dalla parola “femminicidio” che, per molti, è un termine troppo tecnico, abusato, svilente per il fatto di sangue in sé. Per molti giornalisti di cronaca nera ha importanza il reato (l’omicidio), non il genere. La parola, allora, cosa ci indica: il genere della persona o il perchè quella donna è stata uccisa?
La parola «femminicidio» è utilizzata per indicare il motivo dell’uccisione oppure della sparizione di una donna. La parola femminicidio non indica il genere della donna uccisa, ma il motivo per cui è stata uccisa. Il femminicidio accade quando l’assassino sente di non avere più potere e diventa una belva. Diventa un assassino perché non accetta che la donna, che considera di sua proprietà, si possa ribellare. È un accadimento che rientra in un fenomeno trasversale alle classi sociali e alle zone geografiche.
I racconti di femminicidio rispettano quasi sempre una stanca routinizzazione narrativa. Si ripetono tranelli giustificativi come: «amore romantico», «amore malato», «perdita del controllo», «paura dell’abbandono», «raptus». Il pericolo è una normalizzazione di queste interpretazioni?
Credo che da una certa parte del sistema mediatico italiano ci sia la volontà di focalizzarsi sulla morbosità e spettacolarizzazione del dolore, promuovendo un’informazione che rientra a tutti gli effetti nella “pornografia del dolore”. Si mettono troppo spesso in primo piano le presunte ragioni dell’assassino: era geloso, non ha sopportato la perdita, ha tentato la pacificazione e, al suo diniego, è scattato il raptus. Nella narrazione mediatica, malgrado il gran rumore, si entra poco e male nel merito della violenza maschile contro le donne: ci sono dettagli macabri e la colpevolizzazione delle vittime. Il contesto viene raccontato come se le vittime “se la fossero cercata” oppure come se fossero state così idiote da non essere capaci di andarsene. Non viene detto che la maggior parte dei femminicidi avviene proprio quando le donne vogliono andarsene, quando cercano di interrompere la relazione. Servirebbe una maggiore consapevolezza e un cambiamento culturale: è la nostra urgenza.