“Dubita che di fuoco siano gli astri, dubita che si muova il sole, dubita che menzognero sia il vero, ma non dubitare del mio amore”. La fedeltà di Antonno verso Giuseppe Tomasi di Lampedusa è tutta condensata in queste parole che Simona Lo Iacono, scrittrice e giudice presso il Tribunale di Catania, ha intrappolato nel suo “L’albatro” (Neri Pozza, 224 pagine, euro 16,50), in uscita oggi in tutte le librerie. Dopo “Le streghe di Lenzavacche” (e/o), nella dozzina del Premio Strega e vincitore del concorso “Leggo Quindi Sono”, e “Il morso” (Neri Pozza), la scrittrice siciliana ritorna con un romanzo, a metà fra biografia e racconto evocativo, incentrato sulla figura di Giuseppe Tomasi di Lampedusa.
Il libro, che verrà presentato alla Ubik di Foggia il prossimo 21 giugno, dona al lettore un ritratto ammaliante di una delle figure più importanti della letteratura italiana, cogliendo con leggerezza, stile e forti evocazioni simboliche, i sentimenti d’inquietudine – nella gioventù e nella vecchiaia – dello scrittore de “Il Gattopardo”. bonculture ha intervistato Simona Lo Iacono.
Lo Iacono, lei ritorna in libreria con un romanzo su Giuseppe Tomasi di Lampedusa narrato in due fasi estreme della vita: l’infanzia e il tempo prossimo alla morte. Bisogna congiungere proprio questi due momenti per trovare l’innocenza, la verità e il mistero di ognuno di noi?
Credo di sì. Il momento finale e il momento iniziale della nostra esistenza aprono un grande squarcio sul viaggio umano, perché fanno luce sulla direzione che abbiamo dato al nostro cammino. In qualche modo sono due momenti che si somigliano, sia perché sono prossimi, entrambi, al mistero, sia perché ci denudano, ci rendono davvero disarmati e innocenti, ci vestono dell’unico abito con cui nasciamo: il nostro talento. Il perché del nostro ingresso nel mondo, il progetto a cui siamo destinati, che sta a noi decodificare.
Ad accompagnare l’infanzia del “principuzzu” Giuseppe c’è Antonno, il suo amico dalla visione contorta e contraria. Com’è nato questo personaggio di fantasia che nei suoi contrapposti pacifica l’inquietudine acerba del piccolo Lampedusa?
È nato leggendo una introduzione di Giorgio Bassani a una vecchia edizione de “Il Gattopardo”. Bassani narrava dell’arrivo di Giuseppe Tomasi e del cugino Lucio Piccolo, poeta amato da Montale, al convegno letterario di San Pellegrino Terme. I due sembravano approdati da un altro mondo. Erano vestiti in modo impeccabile ma erano anche irrimediabilmente venati da una patina di antico, viaggiavano come nell’Ottocento ed erano inoltre accompagnati da un fedelissimo servitore. È stato lui, questo servuzzo fedele e in qualche modo inadatto a quel mondo ad attrarre la mia attenzione. Mi sono detta: e se fosse stato con Giuseppe Tomasi sin dalla sua infanzia? Se lo avesse visto crescere, se questa sua arrendevolezza, questo suo sguardo trasognato e fiducioso, così poco corrotto dai tempi, fosse il vero motivo della vocazione di Giuseppe?
Perché proprio il simbolo dell’albatro identifica Antonno? È stata influenzata da Baudelaire e dal suo albatro poetico “esiliato sulla terra tra le grida di scherno”?
“L’Albatro” di Baudelaire sicuramente ha influenzato la visione di questo magnifico uccello come simbolo del romanzo e della abnegazione che il servuzzo di Giuseppe Tomasi, Antonno, ha verso il suo padroncino amatissimo. Ma bisogna anche dire che l’albatro è un animale sacro e nel mio romanzo è davvero un fortissimo simbolo spirituale, portatore di vita e di speranza. Insegnerà al piccolo principe a guardare la realtà in modo inusuale, profondo, sempre partecipe. L’albatro è un assertore dell’empatia con il destino, felice o triste che sia, dell’uomo.
Lei sostiene che il destino di ogni adulto vada cercato nei suoi sogni di bambino. È così: sono i sogni o i fantasmi a fare di noi ciò che siamo?
Sicuramente i sogni. I nostri sogni sono dei grandi segnali della nostra vera identità. Ci insegnano ciò che siamo. Se stiamo ad ascoltare un sogno, un ideale, un progetto che ci pulsa in cuore, che non ci abbandona e in qualche modo ci governa, siamo sulla buona strada della scoperta di noi. Tutta la nostra esistenza si gioca su questa domanda fondamentale: chi siamo, perché siamo, in che modo siamo. Scoprirci, vuol dire anche identificarci, valorizzare quel talento che ci rende unici, portatori di una scintilla di luce in più nel mondo.
Non sempre accade, però.
Io in carcere insegno ai detenuti minori proprio questo. Identifica il tuo sogno e saprai chi sei. Ti renderai conto, allora, che l’errore in cui sei caduto non era altro che la conseguenza di una ricerca interiore sbagliata, di una pista non ben focalizzata, di un cammino che va nuovamente indirizzato verso il suo tesoro nascosto. Non a caso, la radice aramaica della parola “peccato” non è “sbaglio”, o “errore” o “reato”, ma “freccia scoccata verso l’obiettivo sbagliato”. Ecco, sognare seriamente vuol dire scoprire l’obiettivo giusto. Quindi, quando si tradiscono i propri sogni non si tradisce un progetto qualsiasi, ma il motivo per cui siamo al mondo.
Soprattutto nei suoi ultimi tre libri c’è sempre una figura minore almeno sulla carta, un debole, un ultimo che si rivela capace di cambiare una visione, una prospettiva. Cosa illuminano nella sua scrittura queste figure?
Gli ultimi sono la chiave di accesso al mistero e all’eternità. È per mezzo del debole che io mi scopro debole. È per mezzo dell’imperfetto che io mi scopro imperfetta, sbeccata, bisognosa degli altri. Attraverso l’ultimo io scovo la mia vera natura, che è traballante e incerta, precaria e bisognosa di paternità. Scovo quindi la mia radice più profonda: la mia necessità spirituale di alleanza con il debole, la mia disperata necessità di bene, di carità e compassione verso l’altro.
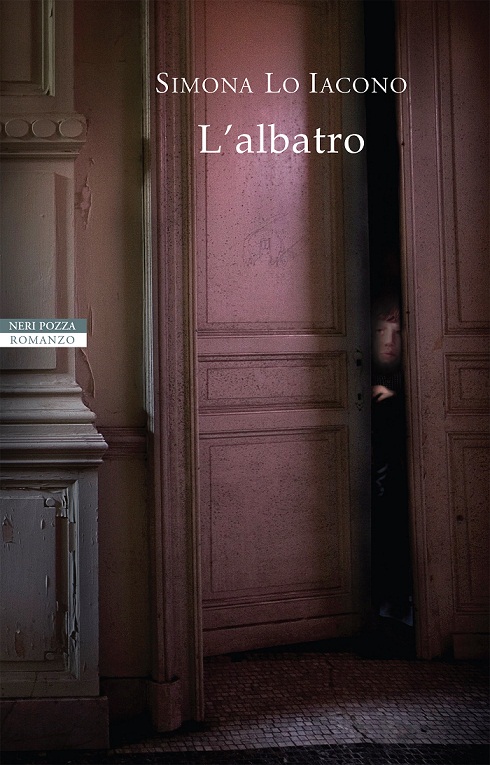
“L’albatro” nelle ultime pagine racconta i primi tentativi falliti di pubblicazione de “Il Gattopardo”. Cosa rappresenta oggi quel romanzo che parla cinicamente della sua terra, dell’irrequietezza di un mondo nobile oramai decaduto, del potere che cambia per non mutare mai?
È uno specchio lucidissimo delle dinamiche del potere. Anche se sganciamo “Il Gattopardo” dal racconto della decadenza della nobiltà, comprendiamo che Giuseppe Tomasi aveva saputo vedere benissimo nel destino futuro: cioè nella ripetitività della logica del forte. Che cambierà solo la maschera, il nome, il marchio, l’appellativo alla propria famelica voglia di restare in piedi, caparbiamente abbarbicato alla sua posizione dominante. Ma sarà sempre uguale a se stesso. Sia che si chiami dittatore, sia che si chiami nobile, o re, o presidente, se il detentore del potere non si fa debole, facendosi quindi servitore e non padrone, resterà sempre un famelico razziatore, vestito d’apparenza.
Perché tutto resti com’è, bisogna che tutto cambi…
Esatto, è così che si spiega la famosa frase detta da Tancredi. Una frase a torto ritenuta simbolo di staticità. In realtà è un’analisi lucidissima, amara e molto vera di come il violento riesca a restare tale, semplicemente cambiando, all’occorrenza, abito e volto.
Il suo, però, è anche un libro sulla scrittura che domina il tempo della morte e sulla forza delle parole che fanno esistere ognuno di noi prima di nominare cosa e chi siamo. Come si compie questa magia?
Si compie perché la parola è portatrice di vita. Una vita rinnovata proprio dalla fine delle cose, perché ha la forza non solo della memoria ma anche della testimonianza. Per questo motivo la parola per essere davvero significativa deve necessariamente affondare nella verità. Se parola e verità non stanno insieme, non si può compiere nessuna magia.

