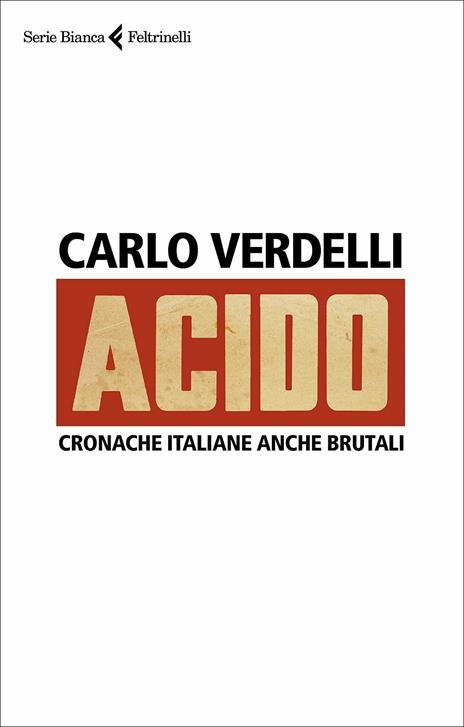In ogni storia, brutale o meno che sia, il graffio sottile di Carlo Verdelli lascia una traccia inconfondibile. Dai dettagli al tono, dalla lealtà alla passione artigianale: quello che conta, nel suo giornalismo, è la qualità del racconto, lo sguardo non banale che apre orizzonti poco visibili, la forma che mette ordine, la parola giusta che arriva e chiarisce. Il suo ultimo libro, “Acido. Cronache italiane anche brutali” (Feltrinelli, 304 pagine, 19 euro), è una dichiarazione laica di fede e di amore nei confronti del mestiere, del giornalismo come professione civile.
In questi quaranta pezzi scritti su carta, tranne il congedo da Repubblica pubblicato online, Verdelli racchiude la sua carriera e svela implicitamente il suo metodo di lavoro. Un metodo di scrittura che è molto simile a un cammino: con il passo disciplinato, il portamento elegante, il fiato giusto e il ritmo che il giornalista possiede e regola. Un manuale di forma giornalistica e passione, che rimarrà, come alcuni attacchi perfetti di Verdelli. «Qualunque cosa ci sia dopo, il niente o Dio, è molto probabile che Enzo Tortora non riposi in pace». Da manuale, appunto. bonculture ha intervistato Carlo Verdelli.
Verdelli, partirei dal titolo del suo libro: “Acido. Cronache italiane anche brutali”.
Acido è una parte per il tutto. All’interno del libro c’è la storia della coppia dell’acido che a Milano ha aggredito tre persone. È una storia che non ha precedenti nella mappa criminale italiana. In quella vicenda, nata nella Milano per bene, quella dei bar di Corso Como e del liceo classico Parini, credo ci siano i sintomi di una perdita di doti morali che mi è sembrata emblematica per uno scivolamento verso disvalori ai quali non eravamo abituati.
Perchè brutali, invece?
Il sottotitolo è legato a un’intervista a Iacopo Melio, attivista per i diritti civili nato con una sindrome rara e dall’anno scorso consigliere regionale in Toscana. In un’intervista gli chiesi: quanto pesa? Quanto è alto? Lui mi disse che non si era mai pesato, che non si era mai misurato. Pesava forse 25 chili, misurava più o meno 1 metro e 30. Questi due particolari, in un pezzo giornalistico, credo facciano la differenza perché ti permettono di visualizzare una persona, un oggetto, una cosa. Lui mi disse: ho fatto parecchie interviste, ma non ho mai trovato uno così brutale come lei. Io ho risposto: brutale sì, ma preciso. Questa brutalità finta, che non è brutalità ma curiosità per il dettaglio, rende immediata la capacità d’immedesimazione del lettore.
Ci sono storie, ritratti e racconti che riescono a oltrepassare l’immediatezza della cronaca. Queste storie sono resistite nel tempo?
Secondo me sì. Prescindono da quando sono accadute. Io riporto un’intervista del 1981 a Lucio Dalla. Aveva 38 anni e l’ho inserita nel libro perché ricordo che quando lo vidi era come essere di fronte a una persona che poteva avere 38 oppure 100 anni. Aveva uno sguardo sulle cose e sul mondo senza tempo. Ecco, quel dialogo con Dalla si può leggere ancora per il suo valore, al di là della sua attualità.
Queste storie raccontano un certo tipo di Paese.
Compongono un mosaico dell’Italia che c’entra poco con l’immagine del Paese in progresso, in movimento verso orizzonti contemporanei. È un’Italia che zoppica, che restituisce pezzi che si incastrano nella loro imperfezione umana. Anche i personaggi più famosi che racconto, come Gassman, vengono ritratti nella loro fragilità. È un’Italia della fragilità esistenziale quella che tratteggio. “Acido” non ha nessuna pretesa di avere un valore sociologico o teorico, ma sentimentale.
Nel lavoro giornalistico è più importante la ricerca del punto di vista o della verità?
Io non credo che un articolo possa rappresentare una verità. Non credo alla formula dei fatti separati dalle opinioni: i fatti non esistono, dipendono da come li racconti. In questo libro ricordo la storia di Rosa e Olindo. Ricostruendo il loro caso, ho individuato elementi che non tornano rispetto alla condanna definitiva della Cassazione. Ho consegnato ai lettori non un una verità, ma un dubbio: e se non fossero stati loro?
I dubbi sono sempre meno accettati nel racconto. Il giornalismo si è fatto più giudicante?
Alimentare il dubbio è quello che ho sempre cercato di fare. Io credo poco ai giornali che credono di avere la verità in tasca. Il mestiere è quello di avvicinarsi il più possibile a una rappresentazione credibile della verità, dichiarando al lettore che non è importante la verità, ma quello che riusciamo a capire di quella storia.
Molto spesso, però, si comprende male quello che raccontiamo.
Sì, ma un giornale deve saper chiedere scusa. Quando dirigevo la Gazzetta dello Sport un giorno un cronista mi raccontò che Del Piero sarebbe diventato papà. Decisi di fare un titolo in prima pagina su questa notizia molto bella. La mattina successiva Del Piero mi chiamò dicendomi che era una notizia non vera. La moglie non era incinta perché quelle ecografie risalivano a qualche mese prima. Mi sentii raggelare. Scrissi una smentita chiedendo scusa alle persone coinvolte.
Ha sbagliato spesso?
Sì, ma ho sempre avuto l’umiltà di chiedere scusa. Chiedendo scusa si stabilisce un rapporto equilibrato con il lettore. Noi non vendiamo una copia quotidiana della Bibbia: un giornale è un’approssimazione della realtà che cerca di sistemare e raccontare quello che è successo il giorno precedente nel miglior modo possibile.
La cronaca è protagonista di queste storie, un genere che lei affronta con rispetto, tatto, senza spettacolarizzazione. Qual è la misura giusta per raccontare il dolore?
Credo che la misura adatta sia quella di mettersi nei panni di chi stai raccontando, provare a immedesimarsi come se fossi tu l’oggetto dell’indagine giornalistica. Questo non ti dà una complicità, ma una compassione e una distanza quasi naturale che determina un rispetto nei confronti anche di quei colpevoli così colpevoli.
Crede che ci sia ancora un pubblico interessato alle descrizioni, ai particolari, alle sfumature, ai lunghi racconti che vanno al di là del flash, del titolo di una notizia?
Nel giornalismo di oggi avverto una certa fretta, come se le cose fatte al volo, molto spesso senza nessun controllo, avessero più valore solo perché arrivano prima. Questo metodo provoca un riscontro rapido, ma il vantaggio immediato che hai ricevuto nel darla per primo ha un effetto boomerang per la perdita di credibilità che avrai quando dovrai cancellare, mandare via e correggere quella notizia. In un giornale, la cosa più importante è proteggere la credibilità del marchio. Questo è un valore importantissimo: che non è fare tutte le cose giuste, ma farle bene e a vantaggio del lettore.
Lei spera che la debolezza dei giornali, quindi del mezzo, non si trasformi in una debolezza del giornalismo e dei giornalisti. Non crede che questa debolezza sia già una realtà?
Credo che la malattia del giornalismo e la crisi dei giornali sia principalmente una crisi degli editori. Noi viviamo una fase di passaggio, un salto temporale enorme. Molti giornali fanno fatica, quindi la ricetta è tagliare i costi, impoverire il prodotto e dare ai giornalisti meno strumenti per farlo bene, mantenendo però il prezzo sempre uguale. Esistono degli esempi virtuosi come il New York Times. Ha avuto delle difficoltà e si è ripreso rafforzando la carta e investendo contemporaneamente sulla parte digitale, senza danneggiare la prima. Così hanno protetto un marchio, una storia giornalistica.
Lei ha diretto con successo giornali diversissimi: La Gazzetta dello Sport, Sette, Vanity Fair, Repubblica. Come si inventa un linguaggio giornalistico coerente con l’identità di ogni testata?
Io ho fatto avventure diversissime. Non ero mai esperto dei temi principali dei giornali che ho diretto. I giornali credo che siano degli organismi viventi, con una loro chimica, una loro storia e un passato che bisogna studiare e comprendere per entrare in sintonia con la comunità di quel giornale e per adattare quella storia al tempo presente. Bisogna tener conto del linguaggio e degli argomenti. Quando ho diretto Vanity Fair l’idea era quella di fare un settimanale femminile bello, patinato, ma intelligente. Alla prima riunione chiesi: cosa abbiamo nella prossima edizione sulla morte di Norberto Bobbio? Nulla, mi risposero, non è un tema per noi. Chiesi: perché Bobbio non è un tema per le donne? In un giornale intelligente si può parlare anche di Bobbio. Non bisognava dare per scontato chi fosse Bobbio, ma trovare gli strumenti per comprendere perché quella personalità era stata così importante per l’Italia. Il problema è sempre come si racconta una storia.
Edmondo Berselli scriveva che «si è giornalisti perché si è curiosi. E la curiosità non finisce mai, credo». Lo crede anche lei?
Berselli dice una cosa verissima: essere curiosi è una delle precondizioni per cominciare a fare questo mestiere. Fare il giornalista significa raccontare bene una storia. Per farlo servono due qualità: la curiosità per andare al di là della verità ufficiale, per aprire porte che sembrano chiuse, per rompere le scatole a chi ha il potere. E la passione civile: perché il giornalismo è mestiere civile, qualunque sia l’argomento di cui ti occupi. L’informazione fa la differenza: in questa pandemia l’ha fatta fra la vita e la morte, la salute e la malattia. Questo impegno io ce l’ho presente da quando ho cominciato.
Di che cosa è curioso oggi?
Io sono un curioso cronico, sono curioso di tutto. Oggi mi metterei a lavorare su quella parte di società sotterranea, che non si vede, di cui capiamo sempre molto poco. In questo momento contiene da una parte il vasto e composito mondo che si oppone ai vaccini e al green pass: un mondo che ha poco a che fare con la disciplina italiana nei momenti di difficoltà. Dall’altra parte l’Italia uscita dai radar, che diserta le urne alle ultime amministrative, che ha diffidenza non per la politica nazionale, ma per il governo della propria città. Una parte di Paese disinteressato ai meccanismi che, dalla Resistenza in poi, hanno fatto funzionare la nostra democrazia.
Questo libro lo dedica al giornalista Gian Piero Dell’Acqua. Qual è la cosa più importante che le ha insegnato?
È stato un mio maestro. Lo incontrai all’inizio della mia carriera nella nascente redazione milanese di Repubblica. Io scrivevo dei pezzettini, ma lui era attentissimo a ogni singola parola di quei pezzi minori. Diceva: noi pensiamo che i giornali si leggano come vengono composti. Invece non è vero: un lettore legge un titolo, salta dalla prima a pagina 37, legge un pezzetto minuscolo o non principale e da quello si fa l’idea di tutto il giornale. Bisogna farlo perfetto. Questa è una regola che non ho mai dimenticato.