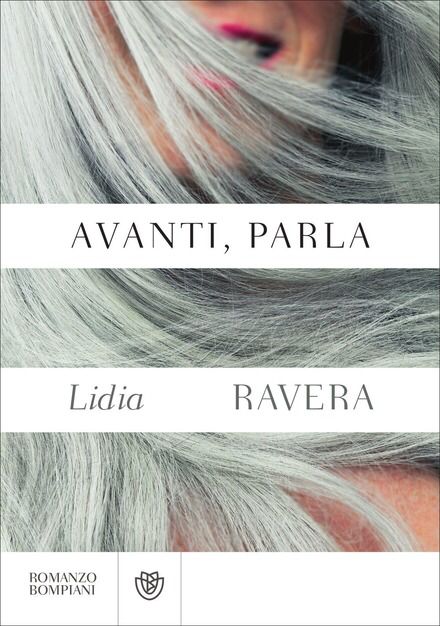Chi sono diventati gli inarrestabili giovani della lotta armata degli anni Settanta? Dov’è finita l’euforia e la voglia di cambiare il mondo, di ridefinire la realtà? Se lo chiede oggi, a distanza di quarant’anni dal finale di quella stagione, Lidia Ravera, scrittrice prolifica e storica agitatrice culturale, nel suo ultimo romanzo, “Avanti, parla” (Bompiani, 352 pagine, 18 euro). Seguendo la vita di Giovanna, una reduce pentita di quel tempo di violenza e ribellione che si è chiusa al mondo per espiare ancora, dopo una pena, la sua colpa; Ravera tratteggia e racconta l’ultimo processo a carico di questi combattenti: quello innescato dal terzo tempo, dalla vecchiaia. Un processo di lucidità, di svelamento, di comprensione ultima di verità inesplorate. bonculture ha intervistato Lidia Ravera.
Giovanna, la sua protagonista, ha scelto di isolarsi dopo aver scontato una pena. È una punizione o una salvezza dallo sguardo degli altri questa sua solitudine?
Giovanna vive in una perpetua autopunizione inflitta perché non riesce a perdonarsi. In questa solitudine ritrova i suoi tempi e scava appuntamenti con sé stessa. Lei ha organizzato molto bene questa sua reclusione che, di fatto, è in controtendenza con la vita di tutti noi che abbiamo sempre bisogno dello sguardo degli altri, dell’approvazione degli altri, del riflesso della nostra figura negli occhi dell’altri. Oramai non ci fidiamo più del nostro sguardo, quasi che non esistessimo più se non nella condivisione. Questa vita solitaria è legata al suo senso di colpa: ha fatto delle scelte estreme, di cui paga ancora le conseguenze. Giovanna non è stata abbastanza superficiale o stupida per buttarsele alle spalle.
Lei si è realmente pentita. Dopo la pena, però, che cosa è rimasto di quella colpa?
Ha partecipato ad attività delittuose, ma non è una criminale comune. Io mi rifiuto di considerare i militanti della lotta armata come criminali comuni. Anche quella è stata una scelta di solitudine, perché ci si è posti ai margini della collettività. Mi premeva raccontare che dietro quelle scelte c’era l’urgenza, forse ingenua o fallace, di provocare un’insurrezione, di costruire una società diversa.
Non è andata così.
Oggi fa ridere, ma all’epoca noi ci credevamo. Anch’io credevo che la società dovesse cambiare, anch’io mi sentivo orfana della guerra partigiana, di una democrazia bloccata e imperfetta. A vent’anni mi sembrava inaccettabile vivere in un mondo diseguale.
Lei, però, non ha scelto la pratica della violenza.
Non avrei e non ho mai accettato la violenza. Chi ha scelto le armi si è allontanato da noi. Quella era una minoranza, ma non sparuta perché aveva un seguito. Io ho continuato a fare politica nel gruppo di Lotta Continua, che poi si sciolse. Dopo il grande riflusso, ognuno se l’è vista con sé stesso. Dall’ora, le sorti del mondo sono diventate scelte personali. Di certo, mai più collettive.
Non racconta una stagione eroica, ma le macerie di quel tempo di rivoluzione. È sbagliato considerarla una sconfitta della sua generazione?
Non è stata tanto una sconfitta: la mia generazione almeno ci ha provato, quelle nate dopo no. Se non ci provi, non sei sconfitto. Noi abbiamo provato a trasformare la società, ma non ha funzionato. Di quel tempo ricordo una tensione rabbiosa verso un modello di società più equa e giusta, che non era così semplice instaurare – e infatti non ci siamo riusciti. È alla mia generazione e alle lotte delle donne, però, che si deve lo svecchiamento di questo Paese. Sono stati anni di piombo e di velluto, di conquiste e battaglie. Sull’onda delle manifestazioni delle donne è passata la legge 194. Poi ancora il divorzio, il diritto di famiglia, lo statuto dei lavoratori. Le lotte di quel tempo non hanno portato alla rivoluzione, ma a un Paese più moderno. Quindi, andiamoci piano a parlare di sconfitte. Noi qualcosa l’abbiamo fatta, ma cos’ha fatto la generazione dei miei figli? Oltre agli aperitivi, intendo.
Di certo nessuno ha coltivato più l’illusione di cambiare il mondo.
Nessuno si sogna più di cambiare il mondo perché tutti lo subiscono per quello che è. I miei figli adottano comportamenti virtuosi, sono tutt’altro che riconciliati, ma si oppongono alla realtà con l’ironia, con un sorriso amaro, ma non hanno nulla a cui appigliarsi. Non farebbero neanche politica perchè oramai la politica è molto sputtanata. Quando ero giovane ho messo la politica al centro della mia vita. Insieme alla letteratura, cercando di farmela perdonare perché era poco ben vista.
L’utopia ha ceduto il posto alla disillusione?
Sì, viviamo un tempo di disillusioni, ma è un alibi. È troppo facile fare solo la pars destruens. Le generazioni dopo le mie sono intelligentissime, lucide, colte, ma disilluse. Bisognerebbe sporcarsi le mani. Uso questa metafora sfibrata non a caso. Lottare è qualcosa che impari da giovane, e non credo tocchi a me che sono decrepita ricominciare da capo. La mia ultima battaglia è quella sull’età. Voglio rivalutare la vecchiaia perché sono stanca di vederla disegnata come pura perdita.
Una battaglia centrale nel libro perché incontriamo Giovanna nel suo terzo tempo, quello della vecchiaia. Questa empatia finale riesce a combattere una certa indulgenza giovanile?
Giovanna non è indulgente con sé. Forse è l’unico tratto in comune: siamo più severe con noi stesse che con gli altri. Non essere indulgente è fondamentale perché la vecchiaia è un momento di grande lucidità se hai il coraggio di guardare il tuo passato per quello che è stato, senza la glassa dolciastra della nostalgia che rende tutti i sapori stucchevoli e uniformi. Per lei c’è stato un passato sanguinoso, per altri meno drammatico, ma uno sguardo severo ti consente di vivere molto bene l’ultima parte della propria vita. Con la serenità e la forza di chi non si è sottratto al proprio processo.
A maggio sono stati arrestati in Francia alcuni vecchi rivoluzionari della lotta armata nell’operazione “Ombre Rosse”. Sui giornali, però, abbiamo visto le foto di giovani spavaldi, non di anziani provati. Un particolare curioso.
Un fatto iniquo, perché le persone cambiano. Questi delitti sono avvenuti cinquant’anni fa e gli autori oggi sono persone anziane: oggi siamo tutti persone anziane. In questo libro, molto tempo prima della cronaca, mi sono chiesta proprio come si collocasse la lucidità dell’età che avanza con l’ubriacatura di quegli anni. Ho indagato questo dilemma con lo strumento della letteratura.
Chi sono diventati quei ragazzi e quelle ragazze invincibili?
Ho parlato con protagonisti della lotta armata, ho letto molti libri scritti da loro o su di loro. Ho ascoltato molto, ma poi ho dimenticato e ho scritto questa storia. Personalmente ho trovato delle persone cambiate e delle persone poco cambiate: alla fine è una questione di esseri umani. Non tutti hanno avuto il coraggio di una feroce autocritica, restando così adagiati nell’illusione, incapaci di fare i conti con la propria giovinezza. La vita è un viaggio, attraverso Paesi diversi, che sono le varie età della vita: quando hai 80 o 90 anni hai attraversato molti Paesi, e ti trovi nell’ultimo o nel penultimo. Perdi qualcosa, ma è un itinerario: puoi incontrare il tuo Io estinto, quello della ventenne, della bambina, della cinquantenne. Sono tutti Io, ma sono diversi. Io diffido delle persone che per tutta la vita rimangono uguali. Gli ultimi anni sono quelli in cui sei più forte e migliore.
Negli anni Settanta la cattiva parola ha costruito mondi e determinato azioni. A distanza di anni c’è una parola che non direbbe più?
Era tutto un po’ astratto. Ricordo alcuni slogan infami: «Per i fascisti basta una sfilata, prognosi prognosi riservata». Erano slogan violenti, che auguravano morte e malattie. Non vado fiera di queste frasi e, in genere, dell’uso comiziante della parola. Anche gli stessi volantini con cui le BR affermavano la paternità di certi crimini avevano un linguaggio astratto, tecnico, lontano: era come se dovessero mettere un sipario di parole fredde fra sé stessi e le proprie vittime. Giovanna racconta che non voleva mai guardarli in faccia, non voleva vedere e credere che fossero esseri umani come lei. Quei volantini e quelle parole ripetute e sfibrate erano brutte, deformi, infami. Stabilivano una distanza per rendere più tollerabile quello che si faceva.
In quegli anni c’erano verità ritenute incrollabili, solidissime. Lei ha cambiato qualche idea, qualche giudizio?
Sono ancora critica nei confronti di questa nostra democrazia zoppa. Alcune cose le penso ancora, altre no. All’epoca avevo fondato un giornale, “Il pane e le rose”, che parlava di femminismo, di musica, di libertà sessuale, della necessità di far godere tutti della cultura e della bellezza. Questa cosa la credo ancora. L’ho creduta anche quando ho fatto l’assessore regionale in Lazio. Oggi, dopo anni, credo ci sia una continuità culturale perché mi ritrovo a desiderare per il mondo le stesse cose di quando facevo “Il pane e le rose”. Ovvero: bellezza e felicità. Che sono piccole conquiste, ma conquiste di libertà, di difesa.
Scrive: «La politica diventa etica se la guardi da lontano». Anche questa è una prospettiva ultima?
Se raggiungi lo sguardo critico della lontananza c’è la distanza giusta per vedere le cose. Comprendi, in controluce, la ragione profonda. Per comprendere qualcosa devi fare qualche passo indietro, devi conquistare una giusta distanza. Ora credo sia arrivato il momento di comprendere alcune cose. Chi ha favorito le bombe di Piazza Fontana? Non lo sappiamo ancora.
Oggi, nel tentativo di chiudere quel decennio, servirebbe una parola di verità o un percorso di giustizia?
È strano che siano alternative. Io penso che non ci sia giustizia senza verità, e che serva una parola di verità per ottenere un pezzo di giustizia.
Il titolo del suo romanzo potrebbe essere un invito per tutte quelle persone che non hanno ancora ricostruito quel tempo. Dunque: Avanti, parlate.
È una ferita ancora aperta e non è il più tempo per stare zitti. Bisogna parlare, capire, guardarsi indietro, comprendere. Bisogna usare il tempo per quello che è: un disinfettante se utile a comprendere, altrimenti aiuta a rendere tutto putrido. Bisogna finalmente parlare: ora sarebbe proprio il caso.