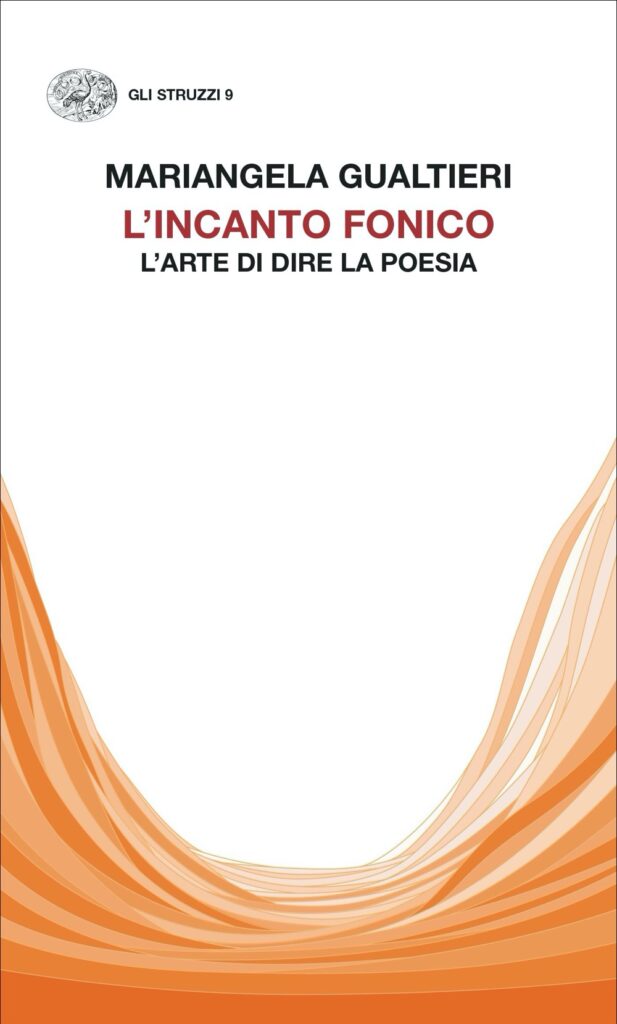La voce e il respiro. Poi il silenzio, le pause e l’ascolto. Sono questi gli elementi centrali nei piccoli e preziosi appunti poetici sull’arte orale della poesia scritti da Mariangela Gualtieri, una delle voci più apprezzate della nostra scena poetica contemporanea. “L’incanto fonico. L’arte di dire la poesia” (Einaudi, 168 pagine, 14 euro) è un concentrato di grazia, un manuale di meraviglia, urgenza e attesa. La poesia, spiega Gualtieri, è un rito sonoro, un magico fatto acustico che, attraverso la «nuda voce più nuda», libera e rivela la natura più profonda delle parole. Ogni poesia, «che implora un respiro che la dica», è musica. E le poesie sono spartiti musicali che aspettano con urgenza una voce per far vibrare i corpi. Per far respirare i corpi. «Noi siamo nel respiro. Attraversiamo ancora».
bonculture ha intervistato Mariangela Gualtieri.
“L’incanto fonico” indaga il mistero dell’arte di dire la poesia. «Migliaia, milioni di versi che chiusi nelle pagine dei libri aspettano voce», scrive. Qual è – e come si cerca – il suono della voce più adatto per dire la poesia?
Quello dentro la propria voce è un lungo viaggio, una speciale avventura che non saprei riassumere in poche battute. Tuttavia, non si tratta di scegliere fra un suono adatto e uno non adatto, piuttosto occorre aprirsi a un ascolto acuto della propria voce e arrivare il più possibile a una schiettezza, a una voce che sappia proferire senza tecnicismo e cliché, paure e gabbie, senza quelle maschere che tutti indossiamo in risposta all’aggressività del mondo.
La sua poesia si immerge in un rito acustico fatto di onde, vibrazioni e silenzio. È l’intensità del silenzio a riscrivere e a far diventare materia viva i versi?
È un insieme di elementi, fra i quali il silenzio ha una grande valenza. Dentro il verso, parola e silenzio sono per me entrambe poesia: hanno lo stesso peso, come trama e ordito di una stessa tessitura. E dunque bisognerebbe farsi esperti di entrambi.
Nella raccolta “Fuoco centrale” scriveva che la sua poesia «nasce a ridosso della scena». Il suo rito poetico è molto legato al corpo, a un trasferimento di energie, a un vero e proprio abbandono nel magma della lingua. Il corpo, centrale nella pratica teatrale, cosa determina in questo rito che tutti noi immaginiamo più legato all’intelletto?
Il mio lavoro in teatro, in particolare nel teatro di Cesare Ronconi, parte proprio da una sorta di drammaturgia dei corpi. Gli interpreti, coi loro attributi, peculiarità e unicità, sono il primo elemento della scrittura registica. Intorno a loro si va poi a tessere tutto il resto. Anche il testo viene dopo e, spesso, nasce per servire quelle facce, quei corpi e tutto il dinamismo corale che da loro scaturisce. Dunque, non la realizzazione di un progetto ma un ascolto acuto del presente e dei doni che porta e rivela.
In queste pagine c’è un elogio della poesia detta a memoria. La memoria libera le parole, le rischiara, le consegna all’eternità?
La parola eternità legata all’umano e alle sue opere è sempre più stridente. Chissà se e quanto dureremo come specie, tutto pare sempre più vacillante. Imparare a memoria è un grande esercizio di attenzione, è un modo per adorare una poesia e penetrarla in ogni sillaba, è un modo per averla sempre con sé e ripeterla interiormente o farne dono nelle occasioni adatte. Un modo, dunque, di condividere la poesia e tenerla dentro le nostre vite.
L’essenzialità e la chiarezza sono due elementi stilistici della sua poesia. Da “Antenata” a “Quando non morivo”, la sua prima e la sua ultima raccolta, ha compiuto un lungo percorso di limature. La semplicità e la leggerezza per un poeta sono le mete più complesse da ambire?
Correggo pochissimo nelle mie poesie. Spesso arrivano proprio così come sono scritte sul libro e la parola limature non mi è particolarmente familiare. Come dice Borges, il poeta invecchiando perde in barocchismi e scopre quella semplicità apparente che secondo questo autore è piuttosto una forma di «modesta e segreta complessità». Credo non ci siano mete in poesia, se non la poesia stessa. Poi con gli anni, appunto, e soprattutto nel mio caso col lavoro teatrale che richiede un dialogo immediato con gli astanti, si acquista in immediatezza, si diventa più accoglienti, forse, e i versi ne risultano più trasparenti. Ma la poesia è un’entità sempre dotata di ombra e mai del tutto semplice, forse anche mai del tutto leggera, pur suscitando un’impressione di leggerezza.
Ogni presente, scrive, dialoga con la poesia. La sua, però, conserva le tracce di genealogie, di archeologie, di lingue rotte nel tempo, di mondi rari e, forse, scomparsi. Quale radice antica alimenta la sua poetica?
Credo che ogni poeta sia in dialogo col passato e col futuro e anche un esploratore dell’umano – e non solo – con una capacità di affondo che arriva lì, oltre il nome, oltre il genere, oltre il proprio tempo, dove ognuno è più somigliante agli altri, pur mantenendo i caratteri del proprio tempo poiché ad esso appartiene. La radice arcaica viene forse dal dialetto delle mie nonne, dal loro italiano sgrammaticato e pieno di invenzioni, oltre che ovviamente dallo studio e dalla frequentazione innamorata dei versi degli altri poeti e poete, passati e presenti. E da ultimo dalla lettura assidua del dizionario, non già o non solo per apprendere nuovi termini, quanto piuttosto per cogliere la forza arcaica delle parole che già uso, quel loro vibrare forte: da quelle pagine, che a me sembrano così avventurose e magiche, mi arrivano sempre potenti suggestioni.
«Accade sempre ora/Non si logora/Non passa come gli imperi». La poesia come inganna la dittatura del presente, del tempo, della contingenza?
La poesia appartiene al presente e non può certo indossare altri panni, altro respiro, se non vuole cadere in una Arcadia o in uno sterile sperimentalismo. Ma proprio in quel suo presente tiene misteriosamente le fila del suo misterioso non passare come il tempo ma mantenere una fragranza di nascita, di sempre nuova efficacia.
Spesso ha dichiarato che la lingua corrente, nonostante una finta illusione, non riesce a dire tutto. La poesia può rimarginare questa ferita, può limitare questo fallimento?
La poesia forse non può dire tutto ma può farcene sentire la mancanza e può persino farcela amare. Per questo in poesia la nostalgia ha una così grande pregnanza e una quasi costante presenza. Io penso che la poesia sappia dare le giuste ferite e sappia anzi liberarci da tutti gli anestetici, facendoci entrare nel dolore dalla porta giusta. Credo ci faccia più vivi.
«Aristocrazia degli attenti/La sola a cui appartenere», scrive ancora. Come ci si libera dal rumore di fondo dell’esistenza? La poesia può allenare alla ricerca di una dimensione collettiva più lieve, più profonda?
La sola ricetta che oso dare è già nella domanda: l’attenzione. E non solo fra noi umani che già sarebbe gran cosa, ma a tutto, attenzione a ogni vivente. Allora ci accorgeremmo della bellezza, della preziosità, della meraviglia di tutto.