La maglietta più bella di sempre, quella del 4 giugno del 1989. La vera grande festa di popolo della serie A, a Napoli il 15 dicembre 1991. La mitica occupazione studentesca del 1994. Gli androni delle plafoniere a luminosità variabile, la vita “senza sogni, semplice, come una colata di bitume traslucido e opaco sulla strada di casa”, dei foggiani, professionisti del disincanto.
C’è tanto nell’ultimo libro di Francesco Berlingieri “Pallone, asfalto e betoniere”.
Il Foggia certo, il calcio ossessione e amore dello scrittore e libraio, e Foggia, la città. E dentro, nella pianura espansa di cemento, palazzi e tifo forsennato che valica Zeman e il suo mito, una generazione cresciuta negli anni Ottanta e Novanta.
Don’t look back in anger, cantavano gli Oasis di Manchester in quegli anni caotici della nostra adolescenza e giovinezza pre Genova. Nello sguardo di Berlingieri non c’è rabbia, non c’è nostalgia, la rivoluzione non parte dal letto della cameretta, ma dagli scompartimenti dei treni diretti a Torino, nella curva Sud dello Zaccheria, in una appartenenza unica e corale. C’è la consapevolezza di una autenticità forse perduta, nella disillusione tipica dell’età adulta, ma anche nella disposizione dell’anima dei ragazzini attuali, ormai piegata al marketing, alle stories Instagram, alle immagini permanenti.
Il libro, un mix di ricordi, saggio antropologico, diario collettivo, è un tuffo in una Foggia che non c’è più, perché ora la città è una immensa periferia slabbrata, senza riti né eroi. È incredibile come il lettore che conosce il calcio superficialmente e non va oltre Maradona, Baggio, Pagliuca e Beppe Signori all’inizio sia preso dalle descrizioni del Tavoliere, dai meccanismi inconsci di un popolo con la sindrome d’inferiorità cucita sulla pelle e il provincialismo patologico, ma poi si appassioni in maniera travolgente al racconto della squadra, delle trasferte, delle partite in casa. Accade sicuramente il contrario a chi del Foggia Calcio conosce a menadito ogni vetta e ogni caduta.
Berlingieri è una penna formidabile, il suo stile illumina sempre qualcosa che avevi sotto gli occhi eppure non avevi mai visto, con parole che sono lame, diagnosi fantastiche e terribili.
Si lancerà in un romanzo? Glielo abbiamo chiesto.
C’è un collegamento con i tuoi precedenti scritti, Francesco?
C’è Foggia, c’è il Foggia, c’è una comunità che mi piace descrivere.
C’è un forte tratto autobiografico anche in questo nuovo lavoro, molti critici oggi condannano l’autofiction, di cui tanti hanno abusato…
Io so parlare solo di ciò che ho vissuto. È un mio limite, lo so. Ma è anche una piccola garanzia di autenticità. Non so cosa sia l’autofiction. So che quando si parla di comitive di ragazzini in giro per i quartieri, di trasferte al seguito di una squadra di calcio, di amicizie che non mutano e pure di qualche scazzottata, si parla di un patrimonio immateriale comune e diffuso, da Nord a Sud. Parlare con chi mi dice che si è immedesimato – o che ho tirato fuori una storia rimossa – è uno dei motivi per cui mi ostino a scrivere.
C’è nel cinema, nelle serie TV, nei costumi un forte revival degli anni Ottanta, cosa rappresentano per te al di là dell’aspetto meramente biografico? C’è qualcosa di politico e di autentico che si è irrimediabilmente perso?
Gli anni Ottanta sono anni di paure collettive – l’eroina, l’Aids, Chernobyl, Alfredino, il mostro di Firenze – e di accesso incontrollato al benessere di massa espresso in consumo; del Rapido 904 e della Fininvest; della morte della politica e del trionfo del disimpegno. Un decennio di contraddizioni profondissime di cui ricordo, con affetto, la dimensione delle comitive di strada. Se c’è qualcosa di politico che si è perso, è questo: il numero e la socialità.
Cosa lega il calcio alla crescita urbanistica bulimica della città?
Foggia è come uno di quei comuni medievali che, nell’incapacità di sanare le proprie faide interne, deve ricorrere al signore. La Foggia del boom dei primissimi Novanta è il frutto meglio riuscito di un forestiero talmente potente e protetto da poter dettare le regole senza dover scendere a compromessi con una moltitudine di soggettività. La crescita urbanistica rientra in quel quadro di dinamismo/sviluppo/sperpero che era precondizione di tutto il resto; che a un certo punto si è arenato e ci ha lasciati orfani e soli. Duole dirlo, ma è così.
Sei una penna piena di talento, hai nel cassetto qualche personaggio? Ti senti pronto per il grande passo del romanzo?
No. Come dicevo prima: so scrivere solo ciò che vivo. Non ho fantasia, non so inventare. Anche se mi piacerebbe molto saperlo fare.
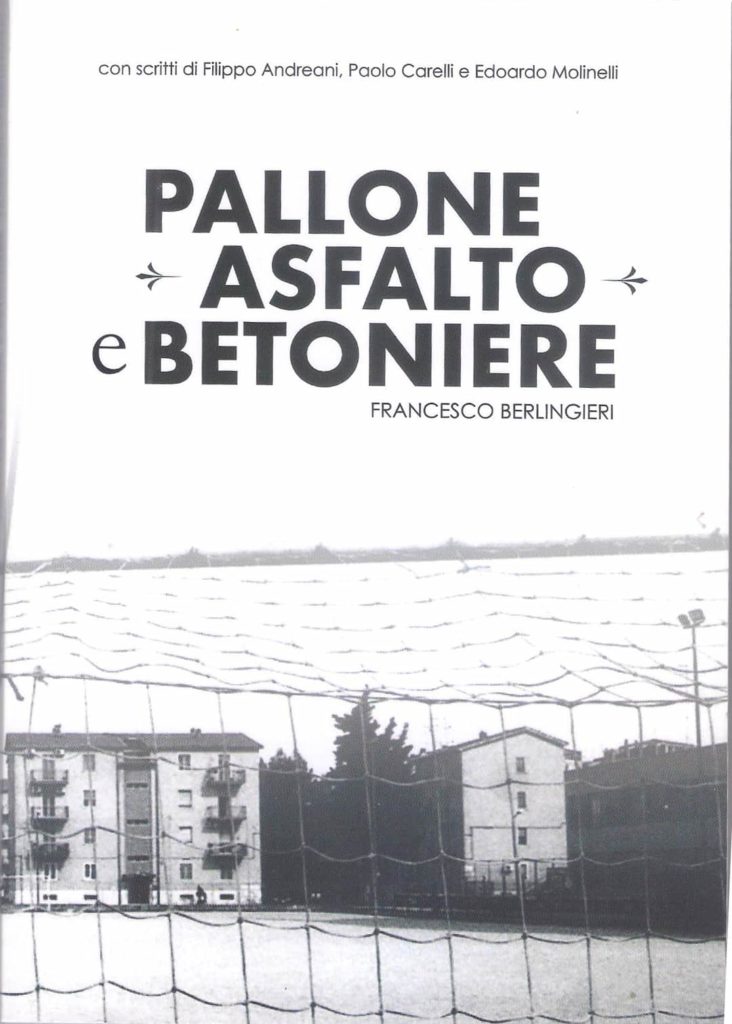
Pubblichiamo uno stralcio di “Pallone, asfalto e betoniere”
Noi e loro
Di fatto, fino al 1980 non è successo niente.
Eppure noi e loro, anche impegnandoci di più e meglio, non potremmo essere più diversi da come siamo. Da qualche parte la farmacie agricole, i palazzoni che cingono il centro come estranei in ascensore, la pianura che d’estate sembra la Castiglia e che si interrompe per diventare collina o roccia o mare quando già, per noi, ha perso prossimità. E interesse. Da quella, i chioschi di Peroni sul lungomare, la Casa dello studente, gli scogli, la Regione Puglia dietro la linea della ferrovia. Da questa parte l’olio crudo, pasta rucola e patate, la flemma di chi passa il tempo, la diffidenza di chi s’è fatto introverso per eccesso di spazi aperti. Da quella, l’ospitalità di chi ha il porto commerciale e il tempo lo monetizza. Istinti mercantili, diceva qualcuno. E l’olio sfritto con l’acciuga nelle orecchiette. Già gli antipodi. Le Australie. E l’Ofanto in mezzo. Centodieci chilometri dal ponte a Palese. Centodieci chilometri per dividere gli Iapigi in Dauni e Peucezi.
Eppure, fino al 1980 non è successo niente. O quasi.
Al “Della Vittoria” e allo “Zaccheria” si andava, in ogni categoria, portandosi addosso il peso della propria assoluta incompatibilità. Con la fierezza della propria diversità. Che diventava orgoglio nella certezza di non essere come chi si andava a trovare. Vessilli rossoneri e biancorossi, più o meno rarefatti, hanno sempre popolato i settori “ospiti” (usando un termine filologicamente inesatto, utile per capirci). Poi la terra tremò in Irpinia. Gli irpini, pure, sono nostri confinanti. Come i molisani. Ma nei loro confronti non ho mai sentito gli strali dei miei nonni. I baresi, i baresi. c’erano sempre loro- razza maledetta!- nelle pieghe d’ogni rivendicazione, di ogni rancore, di ogni recriminazione. Più o meno vittimistica, più o meno fondata. Ma questa è una digressione.
Si diceva della terra. Del terremoto. 23 novembre 1980, a sera. Decimo grado della scala Mercalli. Il Foggia ha appena strappato il pari al Milan. Tanti foggiani sono in treno, di ritorno dal “Meazza”. E non sanno del panico, dei crolli, della nottata all’addiaccio di amici, parenti e concittadini. Ci è andata bene. Poco più in là, sull’Appennino, ci sono stati i morti. Tanti. Quasi novemila. Un cataclisma.
La domenica successiva viene rinviata la partita del Napoli, mentre l’Avellino- che pure gioca in serie A- tornerà al “Partenio” solo a fine gennaio. Il Foggia impatta col Pescara, la Bari cade a Varese.

