Nel poderoso volume del sociologo Jeffrey Alexander, “Trauma. La rappresentazione sociale del dolore” (Meltemi, 332 pagine, 20 euro) colpisce una frase del teorico letterario Geoffrey Hartman: “Gli studiosi più impegnati sul tema spesso parlano di un eccesso che resta buio e spaventoso. Qualcosa al centro dell’evento della Shoah resta oscuro. Una comparazione con la Rivoluzione francese può essere d’aiuto. La sequenza Rivoluzione Francese-Illuminismo non può essere trasposta nella sequenza Olocausto-Illuminismo. Cosa dovrebbe andare dopo i due punti, Eclissi dell’Illuminismo? Eclissi di Dio?”.
C’è già tutto, dell’essenza di questo libro importante, in queste poche parole, compreso il buco teorico e morale che resiste quando si parla dell’Olocausto. Come scrivono i curatori, “la figura di Alexander”, poco conosciuta in Italia, “può essere annoverata di diritto tra quelle dei maggiori teorici sociali contemporanei”. Il saggio in questione, che parla di traumi storici partendo dall’Olocausto per arrivare a Nanchino, è una degna prova dello spessore di questo sociologo americano che proprio sulla teoria del trauma culturale ha costruito una sua cifra di ricerca. La sua versione, prettamente costruttivista, ha ribaltato i tratti profani della teoria del trauma: secondo Alexander, infatti, quelli che noi consideriamo “traumi” non sono semplicemente eventi in sé, ma sono i prodotti delle rappresentazioni sociali, di una complessa spirale di significazione. Gli eventi, quindi, non sono traumatici nella propria natura intrinseca, ma lo sono le loro rappresentazioni mediate culturalmente. Una riflessione del genere ci interroga sull’effettiva capacità di ricordare i traumi collettivi: perché ricordiamo Auschwitz e Srebrenica no? Per Alexander la risposta a questa domanda è tutta nella qualità della “performance”, come la definisce l’autore, che riusciranno a sviluppare i gruppi portatori coinvolti. Costruire un trauma significa drammatizzare una storia, un corredo di simboli e significati che rispondano a quattro interrogativi: la natura del dolore (cosa è successo), la natura delle vittime; il rapporto di empatia fra vittime e audience e l’attribuzione delle responsabilità degli eventi. “Lo status di trauma viene attribuito a fenomeni, reali o immaginari, non tanto sulla base della loro effettiva pericolosità o della loro oggettiva imprevedibilità, quanto piuttosto sulla base della rappresentazione di quegli eventi come pericolosi o imprevisti per l’identità collettiva”.
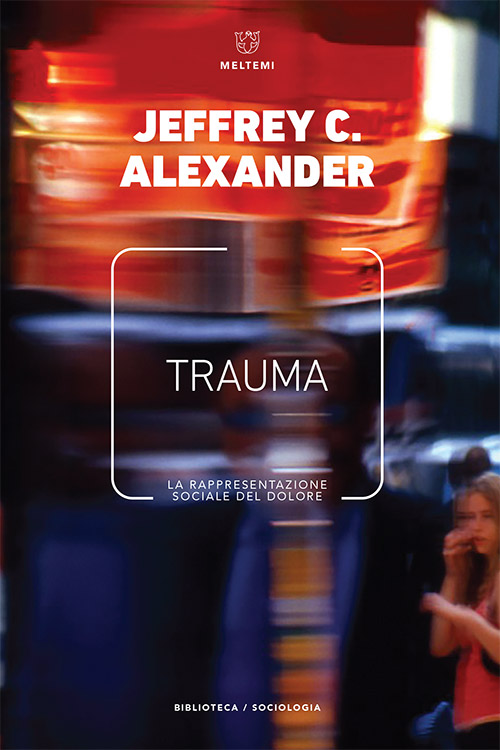
L’Olocausto
Nonostante non sia l’unico trauma storico analizzato, quello dell’Olocausto resta un modello perfetto nell’analisi di Alexander. La trattazione di uno degli eventi più tragici della storia dell’umanità parte proprio da una domanda che riesce a spiegare bene la costruzione simbolica dei traumi. Alexander, infatti, si chiede come sia stato possibile che un genocidio così situato e specifico, inserito in una cornice di oggettivazione che richiamava in primo luogo l’atrocità del secondo conflitto mondiale, sia stato preso a modello, a simbolo del male universale e morale. La risposta è in una lunga trattazione che costruisce la narrazione dell’Olocausto inserita prima in una cornice “progressista” e poi in una diametralmente opposta, quindi “tragica”.
Prima del tragico
Nell’aprile del 1945, quando i soldati americani cominciarono a liberare i primi campi di concentramento, l’Olocausto non aveva nessun significato rappresentativo. Come ricorda Alexander “affinché un evento traumatico riceva lo status di male, esso deve diventare il male”. Ma doveva diventare male, allora, dopo un processo di conoscenza, codificazione e rappresentazione che riuscisse in primo luogo a comprendere la natura specifica di quel trauma. In questo processo l’Olocausto venne tipizzato e collegato al nazismo. Il nazismo, in quanto male assoluto dell’epoca, divenne la narrazione preminente: lo sterminio degli ebrei fu infatti interpretato inizialmente e “semplicemente” come un’altra orribile manifestazione della natura violenta e disumana di quello specifico regime. Una tragedia circoscritta nell’ambito di una guerra, di un conflitto, di qualcosa che restava nei limiti di una violenza specifica. In questa codificazione del male, che era il nazismo oramai battuto, lo sterminio di massa degli ebrei venne assorbito in una narrazione progressista, in un modo che guardava oltre, alla promessa di salvezza che sarebbe arrivata dopo l’orrore. Non c’era dunque spazio per i campi di concentramento e Auschwitz: il male del nazismo era alle spalle e quel sangue versato dal popolo ebraico, come accade nelle guerre, avrebbe santificato la pace futura e fatto dimenticare il passato.
Nel tragico il senso
La narrazione progressista, però, nella sua rappresentazione mancava di un punto fondamentale. Auschwitz e l’Olocausto non potevano essere semplicemente gli effetti di una guerra perché erano le conseguenze di un male che minava la radice dell’umanità, quindi unico nella storia. A rafforzare questa idea, come teorizza Alexander, arrivò una cornice di narrazione tragica: una struttura culturale che ci ha restituito il trauma dell’Olocausto nei termini e nella gravità che oggi conosciamo. Questa narrazione diede a quell’evento una tipicità unica, qualcosa di staccato da ogni possibile conflitto o evento precedente. Non divenne semplicemente il male, ma un male sacro per dirla con Durkheim, qualcosa di incomprensibile nei termini ordinari e razionali, morali e teologici. Non serviva neanche la distanza storica, come suggerì nel 1968 Deutscher in “La tragedia ebraica e la storia”: “Comprendere l’Olocausto non era una solo una questione di tempo. Non ci sarebbe stato progresso”. Ma non poteva esserci nessun progresso, l’Olocausto poteva solamente fornire un’identificazione psicologica e morale. Questo approccio tragico, che non doveva riscattarsi e andare oltre, non offriva nessun lieto fine: bisognava comprendere e assimilare. L’uccisione degli ebrei diventava un macigno pesante nella morale e nel vissuto dell’Occidente che non poteva più essere superato. Con la certezza che nulla era conquistato e che sarebbe potuto accadere ancora, l’Olocausto diventò il male sacro archetipico del nostro tempo. Le rappresentazioni, le identificazioni della sfera sociale con le vittime servirono semplicemente a riscrivere e a rifondare una nuova rappresentazione etica e morale del mondo post-Olocausto.
La cultura
Alexander, seguendo la sua teoria, dimostra che non è l’evento in sé che porta un carico di orrore e tragicità. Dal suo punto di vista teorico il massacro degli ebrei diventò quello che è oggi grazie a una serie di drammatizzazioni tragiche. Fra i tanti richiami che utilizza nel saggio c’è sicuramente spazio per i prodotti culturali che strutturarono narrativamente il tema. A partire dalla miniserie Olocausto, prodotta dalla Nbc, passando per il drammatico racconto di Anna Frank nel suo diario. Il processo di costruzione del senso dell’Olocausto avvenne soprattutto con l’identificazione dell’opinione pubblica con le vittime: bisognava particolarizzare la narrazione, renderla vicina, a portata di tutti. Musei, film, racconti, documentari e testimonianze dei sopravvissuti riuscirono a cristallizzare una vicenda che diventava prima di tutto “umana”, in uno spazio di visione comune che, finalmente, trovava il giusto accordo sui significati e sui valori di quell’eccidio.
Metafora ponte
L’ultimo elemento carico di significato nella tesi di Alexander è quello che lui chiama “metafora ponte”. Ogni trauma che si è verificato dopo il 1945 si è ritrovato a fare i conti con le questioni morali che il massacro degli ebrei avevano sollevato. Grazie alla codificazione universale di quell’evento, alla cornice tragica e a un processo di estensione simbolica e identificazione emotiva (gli effetti del “rigonfiarsi del male”), l’Olocausto si è ritrovato a essere una fortissima metafora ponte che ha definito la morale post Olocausto e la distinzione universale di cosa sia bene e di cosa sia male. In quanto metafora del male radicale, l’Olocausto è stato utilizzato come un margine di paragone comparativo per giudicare gli altri atti traumatici del mondo. Un modello, un paragone, che ha svolto un compito di metafora connettiva per dare senso alla complessa riconoscibilità della vita sociale.
Poter dimenticare
Questa teoria di Alexander è molto interessante e suggestiva per comprendere come sia stato possibile costruire una struttura culturale attorno all’evento più crudele del Novecento, ma non ci dice nulla sulla persistenza di questi sistemi che, appunto, sono culturali, simbolici, rappresentativi e dunque mutabili, non fissi. Nell’introduzione al testo a cura di Migliorati e Mori, però, c’è una critica utile al ragionamento. I due curatori contestano la sensazione di stabilità che Alexander crede possa coinvolgere queste narrazioni, queste memorie sociali: “Così ogni memoria implica una scelta: quella di ricordare, ma anche quella di dimenticare. Ed entrambe si fondano sulle categorie valoriali del presente che incidono sulle rappresentazioni collettive del passato”. Obiezione mai più centrata proprio per quanto riguarda il tema dell’Olocausto. Se i traumi sono somme di rappresentazioni culturali, cosa succederà quando i gruppi portatori di questo trauma, gli ultimi sopravvissuti, non potranno più mettere in scena una “performance” convincente di quello che successe? Cosa succederà se supereremo l’importanza dei significati e dei valori chiave come l’antisemitismo e l’antirazzismo? La risposta potrebbe essere l’oblio o, nell’ipotesi più deleteria, la scelta di ricordare.

