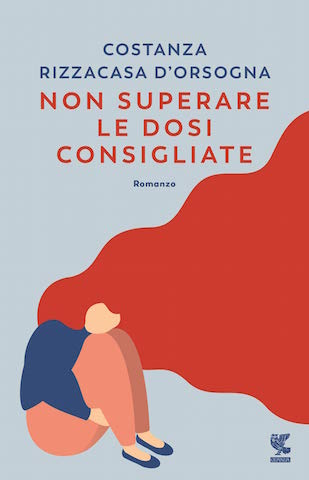C’è un’esistenza spietata e una dose di profondità umana nel primo romanzo della giornalista Costanza Rizzacasa d’Orsogna, firma del Corriere della Sera e del supplemento culturale La Lettura. C’è un mondo di vita che si interroga sui suoi perchè nel suo “Non superare le dose consigliate” (Guanda, 256 pagine, 18.00 euro), un tentativo a metà fra narrazione e racconto autobiografico, introspezione privata e indagine pubblica su un problema sfaccettato e complesso come quello dei disturbi alimentari.
Ci sono confini ed esperienze che l’autrice sorpassa e amplia, indaga con decisione e con una continua ambiguità narrativa: ci si sente assediati da queste pagine, coinvolti in una storia che interroga il lettore pagina dopo pagina sul sottile confine che lega finzione e realtà. La sua protagonista, Matilde, capace di emozionare e indignare, porta con sé molte delle vicende umane dell’autrice, in una trasposizione che include e integra problematiche comuni e diverse come il rapporto con i corpi sbagliati, il perfezionismo, la possibilità di abitare il baratro della rovina e poi le parole crudeli, l’autolesionismo, le bugie e la dipendenza da un mondo sempre più ostile che divide, isola. Costanza d’Orsogna restituisce in maniera vivida questa sensazione di perenne instabilità – fisica, dei corpi, e morale, dell’animo – che è comune a tutte quelle persone che combattono una battaglia contro quell’immagine idealizzata che il mondo prepara e progetta per noi. In un percorso di dolore e sofferenza, che non viene mai negato in un tentativo di sottrazione, il romanzo accoglie e prepara a un passaggio mai scontato e naturale nella vita di ognuno di noi: l’accettazione del proprio Io, nella sua complessa imperfezione fallimentare. bonculture ha intervistato Costanza Rizzacasa d’Orsogna.
Matilde, la sua protagonista, in queste pagine dice: «Avevo perso la lingua. Ho trovato una voce». Costanza come e quando ha trovato il coraggio nella sua voce per parlare di un tema così prossimo alla sua esperienza?
Non so se si sia davvero trattato di coraggio o del fatto che, quando ti dai il permesso di scrivere qualcosa, quando decidi di aprire quella porta, viene tutto fuori, da sé, e dopo che ti sei chiusa in casa per tre anni come avevo fatto io – nascosta, annullata, come sembrava volessero tutti -, senti il bisogno di gridare, di urlare che ci sei anche tu. Ho scritto le prime 75 pagine del romanzo in pochi giorni, in una sorta di trance (solitamente invece sono lentissima, un po’ perché ho paura e un po’ perché in parte penso ancora in inglese, anche se l’infanzia di quelle prime pagine, quando io e Matilde siamo più vicine, la ricordo com’era, e quindi in italiano). Ma sapevo che un libro del genere, su questi temi, doveva essere scritto così: con quella crudezza, quell’autenticità, quella ferocia. E ho sempre saputo che avrei fatto il bene del libro, non mi sono mai tirata indietro. Parliamo di lassativi? Facciamo vedere di cosa stiamo parlando. Che cosa comporta davvero una dipendenza.
Sottolinea spesso, attraverso un racconto del corpo come uno spazio di dolore, che la condanna sociale non è solamente estetica ma anche morale. Si è prigionieri di qualcosa di più di un corpo che muta e si trasforma?
Certo: il corpo è solo la punta dell’iceberg. Si è prigionieri di gabbie, caselle, sovrastrutture. Le proprie e quelle degli altri. Della società, del mito della bellezza, dell’industria delle diete, dell’ignoranza. Alla grassezza sono associate i vizi peggiori: pigrizia, sporcizia. Se di anoressia ormai si parla spesso, ma sempre nel modo sbagliato, di binge eating (il disturbo delle abbuffate incontrollate di cui l’obesità è una conseguenza), non si parla mai. Nonostante sia di gran lunga il disturbo più diffuso nella società occidentale, tre volte più di anoressia e bulimia insieme. Del dolore delle persone obese non si parla mai, se si parla di loro – di noi – è solo per condannarci. Lo ha fatto per moltissimo tempo anche la medicina, classificando come “obesità mostruosa” quella che supera certi parametri. Immaginiamo una persona obesa, che ha problemi di mobilità, forse di salute, che ogni volta che esce di casa viene guardata male e apostrofata peggio. Una mattina questa persona decide di fare qualcosa per migliorare la qualità della propria vita. Va da un medico e quello la definisce un mostro. Lo scrive proprio nella diagnosi: obesità mostruosa. Come si sentirà quella persona? Quando sei obeso, perfino i dietologi non vogliono avere a che fare con te.
A questa “mostruosità” non ha paura di opporre due temi complessi che, per molti, sono alla base di un certo risentimento generale delle nostre società occidentali: il perfezionismo, o più in generale un vitalismo frenetico, e la competizione. Quando si soffre di disturbi alimentari è un gioco al massacro adattarsi a queste dinamiche?
Il disturbo alimentare, che è un disturbo mentale, è sempre un “gioco” al massacro. Il perfezionismo, la competizione, sono cose molto belle sulla carta, ma possono degenerare. È bellissimo che Matilde a tre anni studi il latino e il greco, conosca la Divina Commedia a memoria e quello che vuol dire, ma se non è accompagnato dal lasciar fare a Matilde quello che fa una bambina della sua età diventa pericoloso. La madre di Matilde è una donna profondamente disturbata e insoddisfatta che riversa sulla figlia le proprie aspirazioni, e questo condizionerà Matilde per tutta la vita. Riuscire dove la madre non è riuscita, riuscire per lei e perché le dica “Brava”. I lassativi, che lei non smetterà mai di prendere perché crede che se lo facesse tradirebbe sua madre, sono espressione di tutto questo. A tre anni Matilde si sente il centro del mondo. Ma quando l’attenzione della madre scema, anche perché Matilde la tradisce ingrassando, lei diventa insicurissima. Poi va negli Stati Uniti, dove splende, sì, ma deve anche fare i conti con un culto del vincente che non è più solo della madre, ma della società in cui è immersa. “Competition, competition”, ripete il preside alla orientation, come mantra per le matricole. Ma vincere ad ogni costo genera mostri. Così Matilde, per cui essere la migliore è importantissimo, è sempre in affanno.
In questi anni lei si è battuta molto contro il body shaming, ma questo romanzo è qualcosa di più perchè non contiene solamente una denuncia, ma anche un tratto di luce che risplende fra le vicende narrate. Come ci si salva da quel baratro che, come lei scrive, è sempre lì?
Spesso non ci si salva affatto. I disturbi alimentari, spesso, te li porti dietro per tutta la vita. Potrai guarire, certo, ma sarai sempre vulnerabile. Più in generale, salvare i miei personaggi non m’interessava; come non m’interessava una protagonista che fosse una vittima e basta. Volevo far vedere come una vittima può trasformarsi in carnefice. Questo libro è un’opera letteraria, non un manifesto. Ma forse è ancora di più un manifesto proprio perché non cercava di esserlo.
È un romanzo che parla anche della famiglia, di quelle famiglie disfunzionali in cui coabitano – senza una netta distinzione percepibile – condanna e salvezza. Quanto condiziona la famiglia in questi casi?
Il primo fat shaming è in famiglia. La famiglia ha il grandissimo potere di formare la percezione che un bambino ha di sé, il rispetto e l’accettazione che ha di sé. Matilde cercherà più volte di emanciparsi dalla famiglia, ma vuole anche sempre tornare lì, all’infanzia, a quando a tre anni era la luce degli occhi di sua madre, all’amore incondizionato dell’infanzia, che non chiede nulla in cambio. La mia protagonista cercherà quell’amore incondizionato negli uomini, che ovviamente non potranno darglielo. Lo cercherà, fuori tempo, nel padre, che, impegnato a rifarsi una vita, non potrà darglielo neanche lui. Così Matilde si rifugia nel pane, quello che la conforta sin da bambina: l’unico che non l’ha mai tradita.
La protagonista ritorna spesso alla famiglia cristallizzando la sua personalità proprio nel suo ruolo di figlia. Lei questo libro lo dedica a sua madre, a suo padre e a suo fratello: anche lei si sente ancora figlia?
Certo. Lo sono inevitabilmente perché, per tanti motivi, non ho creato una famiglia mia. Per tanti anni ho pensato ad altro, e quando ho iniziato a pensarci era improvvisamente tardi e non avevo gli strumenti che altri acquisiscono molto prima. Lo sono anche perché non ho ancora raggiunto quel momento in cui si diventa genitori dei propri genitori. Mia madre è morta a 52 anni, mio padre ne ha 73 ed è ancora in salute. Certo, la famiglia ti condiziona, ma è bello essere figli. Sono una donna del mio tempo, quindi un’adultescente, e avendo sempre vissuto da sola, non avendo mai dovuto prendermi cura di nessuno al di là del mio gatto, sono naturalmente egocentrica. Spero di restarlo – un’adultescente – ancora a lungo.
Nel suo tratto emerge una ricerca di bellezza, di armonia, di felicità; concetti che nell’immaginario comune sono erroneamente agli antipodi di tutte quelle persone che soffrono di disturbi alimentari. Per lei che cos’è la bellezza?
(Ride) Non riuscirà a farmi dire che la bellezza è interiore, anche se lo è. Io amo molto la bellezza esteriore, la invidio moltissimo, la cerco e la guardo con voyeurismo. La bellezza di un corpo adolescente, per esempio. Ma la bellezza è una cosa, la perfezione è un’altra. E io trovo che ci sia immensa bellezza, straordinaria bellezza, nell’imperfezione. Le famiglie sono così, disfunzionali e bellissime.
Il racconto spazia nel tempo e nello spazio, dall’Italia a New York dove lei ha studiato alla Columbia University. Provvidenziale, in questo momento, il rimando che fa alla storia di Eric Garner, ucciso dalla polizia nel 2014. Lei scrive: «Giorni fa, gli avvocati del poliziotto di New York che aveva ucciso un afroamericano hanno provato una nuova linea di difesa. Era obeso, hanno detto, sarebbe morto comunque». Questa storia ci ricorda l’assassinio di George Floyd e una continua marginalità delle minoranze. Oggi qual è il suo sguardo, di giornalista e di persona che ha vissuto in quel Paese, su questa ferita mai rimarginata di discriminazione e violenza?
Negli anni Novanta, a New York, andava di moda dirsi “colorblind”, espressione politically correct mutuata dall’oculistica col significato di non vedere alcuna differenza fra le razze. Un concetto oggi superato, tanto che si parla di “colorblind racism”, perché negare la realtà della razza, e quindi del razzismo, può solo perpetuare le diseguaglianze. Dirsi colorblind è in realtà white privilege. Ricordo molto bene, anche, la campagna elettorale ’93 di Rudy Giuliani, che prendeva di petto Harlem promettendo un “civic cleanup”. Nel romanzo, Matilde, che da studentessa della Columbia vive a Morningside Heights, quindi a ridosso di Harlem, osserva che i veri problemi sono invece molto più spesso interni al campus – quelli del “date rape”, che nessuno, neanche l’università, vuole vedere, perché a stuprare le studentesse sono i figli dei ricchi bianchi. Ricordo la discriminazione negli ospedali, e quanto fossi cosciente già allora di un orrore di cui si parla pochissimo, e cioè le amputazioni che i neri subiscono in percentuali molto superiori ai bianchi, perché il corpo nero vale meno. Ma nel parlare e condannare quelle discriminazioni e quelle violenze, non dimentichiamoci di parlare e condannare anche quelle di casa nostra, un Paese dove sul colore della pelle ancora si sghignazza. A me manca moltissimo quel melting pot che è New York City, quella multiculturalità che non devi cercare, c’è e basta, e da cui puoi imparare anche tante cose. Come qualunque diciottenne che sbarchi a New York, Matilde ha avuto fidanzati di tutti i colori e tutte le provenienze, asiatici, neri, Middle Eastern (anche se Matilde, che non si fa mai sconti, a un certo punto si chiede se non andasse coi ragazzi neri perché, preferendo molti di loro ragazze più in carne, sarebbero stati più tolleranti col suo corpo). E nero è un termine generico: Matilde ha avuto un fidanzato di Trinidad, un altro del Mali… Poi però torni in Italia, scrivi un libro che parla anche di questo e la cosa diventa, magari in diretta tv, lo spunto per allusioni volgari: “Ti sei divertita, eh?”. Battute che non solo alla tv americana, ma a quella francese, inglese, tedesca, nessuno ti farebbe mai.